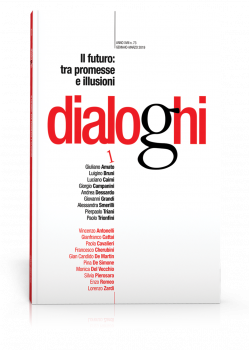Dopo un rapido excursus sulla scuola dall’Unità d’Italia al fascismo, l’autore si sofferma sul sistema d’istruzione in chiave democratica dell’Italia repubblicana, che fu messo in discussione nel Sessantotto, dopo che si era affermata la «scuola di tutti». Questa acquisizione tuttavia con i cambiamenti epocali che si stanno attraversando è destinata al fallimento se non diventa anche «scuola per ciascuno».
Nel contesto italiano possiamo parlare in senso proprio di scuola democratica solo con l’avvento della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948). Dall’unità nazionale (1861) alla fine del fascismo la «questione scolastica» si era via via posta sotto altre prospettive. Vediamo rapidamente.
Tra alfabetizzazione e “fascistizzazione”
Il più grave problema scolastico che la classe dirigente liberale si trovò ad affrontare l’indomani dell’unificazione riguardava l’analfabetismo. Nella maggior parte delle regioni del Sud si giungeva a punte del 90% di analfabeti. L’Italia centrale (in particolare la Toscana) stava un po’ meglio; il quadro, pur sempre problematico, migliorava in diverse aree del Nord (dal Piemonte alla Lombardia). Con una situazione così deficitaria era chiaro che non ci si sarebbe potuti mettere al passo con i paesi europei più avanzati.
Il regio decreto 3725/1859 (detto legge Casati, dal nome del ministro della P.I. conte Gabrio), pensato per il Regno di Sardegna, fu esteso ai territori degli ex Stati pre-unitari che, sotto la regia di Casa Savoia, venivano annessi al costituendo Regno d’Italia. Rappresentò per sessant’anni l’asse portante del sistema scolastico nazionale.
Lo schema dell’articolato legislativo lasciava intendere la logica soggiacente. Si puntava, intanto, a definire, in senso centralistico, il quadro amministrativo della P.I. (Titolo I), per precisare, poi, i profili dell’istruzione universitaria (Titolo II), secondaria classica (Titolo III), tecnica (Titolo IV), elementare (Titolo V). Il modello organizzativo predisposto, consentaneo con una visione stratificata della società e pressoché priva di mobilità sociale, mirava innanzitutto ad assicurare la cura per i percorsi formativi (Università/liceo) delle figure destinate a divenire classe dirigente (le élite), anche se – ovviamente – non potevano essere dimenticati i settori tecnico-professionali e l’istruzione popolare, primo gradino per l’alfabetizzazione.
L’idea democratica applicata alla scuola, in quel contesto, era ben lungi dall’essere tematizzata. Nondimeno, la consapevolezza di dovere investire, per lo sviluppo del paese, sull’istruzione, trovava riscontro nella compagine governativa liberale. Con l’avvento al potere della Sinistra storica (1876), lo sforzo contro l’analfabetismo ebbe nuovo impulso (legge Coppino 3961/1877).
L’istruzione come strumento per incivilire il popolo e superare mentalità irrazionali, pre-scientifiche, guadagnò consenso negli ultimi decenni dell’Ottocento, sotto l’impulso della cultura positivistica, cui attinse a piene mani anche il nascente movimento socialista. Per un futuro “radioso” dell’umanità occorreva, dunque, diffondere, sin dal primo grado scolastico, una cultura “positiva”, scevra da retaggi atavici, alimentati – si diceva – dalla stessa religione. Va ricordato che proprio la difesa dell’insegnamento religioso nelle elementari fu al centro delle battaglie del movimento cattolico sino a fine secolo (e oltre).
Il superamento della legge Casati avvenne nel 1923 con la riforma di Giovanni Gentile, ministro della P.I. nel dicastero Mussolini. Fu definita dal capo del governo «la più fascista delle riforme». In realtà, si trattò di un “progetto” coerente con la prospettiva filosofico-pedagogica gentiliana, che per l’istruzione secondaria e superiore puntava sul primato della cultura classica e su un chiaro accento elitario-selettivo. A livello di organizzazione e di governance del sistema scolastico, l’impianto centralistico, gerarchico e autoritario rivelava i tratti di più immediata convergenza con l’ideologia del fascismo.
Subito investita dalla cosiddetta «politica dei ritocchi», la riforma Gentile subì un graduale processo di “fascistizzazione”, giunto al culmine con la Carta della scuola del ministro Bottai (1939).
Ovviamente, nel ventennio fascista, il sistema scolastico non ebbe nulla da spartire con l’idea democratica. Il rigido controllo su amministrazione, libri di testo, insegnanti, studenti non lasciava spazio alla libera circolazione delle idee e, tanto meno, a eventuali forme di dissenso manifesto. Solo con la caduta del regime si sarebbe potuto dischiudere anche in campo scolastico – come di fatto avvenne – una prospettiva democratica.
La democrazia scolastica in Costituzione
Nell’Italia repubblicana la nuova Carta costituzionale, entro il quadro dei princìpi/valori di fondo, delineava anche i contorni essenziali per ripensare il sistema d’istruzione in chiave democratica.
«L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», recitava l’art. 33. Dal canto suo l’art. 34 dettava i criteri-cardine del sistema scolastico nazionale: «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione obbligatoria, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».
Erano linee-manifesto della scuola democratica della nuova Italia. Ora, dai princìpi generali occorreva procedere con coerenti iniziative legislative di riordino dell’intero quadro scolastico.
A questa impresa si accinse il ministro della P.I. Guido Gonella (1946-51). Lotta contro l’analfabetismo, adempimento dell’obbligo scolastico di otto anni, rilancio dell’istruzione professionale, salvaguardia della libertà in educazione, aggiornamento degli insegnanti furono i suoi principali campi d’impegno. Nell’aprile 1947 prese il via la Commissione nazionale d’inchiesta sulle condizioni della scuola di ogni ordine e grado. Concluse i lavori nell’aprile 1949, corredando gli esiti dell’indagine conoscitiva con la proposta di un ampio piano di riforma. Esso costituì riferimento per l’elaborazione del ddl 2100, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 giugno 1951 e presentato il 13 luglio alla Camera. Ma, a seguito dei sempre più deteriorati rapporti fra le maggiori forze politiche (Dc, Pci, Psi), finì nel nulla, tant’è che non venne nemmeno discusso.
A quel punto la riforma del sistema scolastico in senso costituzionale doveva riprendere da capo. La questione che, per tutti gli anni Cinquanta, più affaticò studiosi, uomini di scuola e politici fu il triennio dopo le elementari. Al termine di un percorso tormentato, con proposte di diverso tenore anche nell’associazionismo cattolico degli insegnanti (i maestri dell’Aimc, da una parte, i professori dell’Uciim, dall’altra), si giunse, finalmente, all’istituzione della scuola media unica: legge 1859/1962.
La nuova stagione di centro-sinistra, con l’ingresso dei socialisti nel governo a maggioranza democristiana, aveva alimentato un clima favorevole al raggiungimento del traguardo. Quanto alla P.I., protagonista di quella fase fu il ministro Luigi Gui, in carica dal 1962 al 1968.
La scuola media unica rappresentò una «pacifica rivoluzione civile», un «grande fatto democratico». Essa, innalzando, secondo il dettato costituzionale, l’istruzione obbligatoria a otto anni, dava intanto un colpo secco alla selezione precoce (dopo le elementari) dei percorsi scolastici, perlopiù legata alle condizioni socio-culturali di provenienza degli alunni. Inoltre innovava sul piano didattico, aprendosi alle metodologie attivistiche.
Conosciamo le resistenze di molti docenti, soprattutto di chi, abituato all’elitaria media tradizionale (distinta dai trienni di avviamento professionale), si mostrava mal disposto verso il richiesto cambio di mentalità culturale e metodologico.
Nel 1967 la Lettera a una professoressa di don Milani e dei suoi ragazzi di Barbiana entrava prepotentemente nel dibattito scolastico. Era un duro atto d’accusa contro le persistenti forme di classismo ed elitarismo selettivo che continuavano a prosperare nella scuola, discriminando i figli dei poveri.
La Lettera fu l’avvisaglia di un processo, sin lì semi-carsico, di profonda insoddisfazione verso il sistema d’istruzione secondaria – ingessato, autoritario, classista –, che trovò sbocco plateale nella contestazione studentesca del 1968. Dalle sedi universitarie la rivolta toccò anche gli istituti superiori, in un crescendo di tensioni e scontri fra studenti, autorità scolastiche, forze dell’ordine. Il timore che le persistenti turbolenze potessero sfuggire di mano indusse governo e forze politiche di maggioranza a correre ai ripari con interventi tampone, in grado, quantomeno, di raccogliere alcune istanze della contestazione.
Si puntò, pertanto, su una risposta che avvalorava l’istanza partecipativa, fortemente sollecitata dagli stessi studenti medi. Ne diede conferma la legge 477/1973, con i relativi decreti delegati del 1974. Introducevano una grande novità nella gestione dell’intero comparto scolastico (dalle elementari alla secondaria superiore), aprendolo a una gestione partecipata su diversi livelli (classe, circoli, istituti, distretti...), con il coinvolgimento di genitori, studenti, docenti, rappresentanze sociali. Fu, per ogni componente chiamata in causa, un importante esercizio di democrazia rappresentativa. Con il passare degli anni, tuttavia, l’esperienza perse progressivamente lo slancio dei primi tempi, scadendo in una routine poco creativa circa l’interscambio fra scuola e società.
Superati i difficili anni Settanta, l’idea secondo cui una democrazia scolastica compiuta richiedesse di orientare l’attenzione su altri registri, come, ad esempio, quello dell’inclusività, andò progressivamente guadagnando terreno. Ne diede conferma la legge 104/1992 sull’inserimento degli alunni portatori di handicap nelle classi “normali”: una decisione d’avanguardia rispetto agli indirizzi prevalenti in Europa, gravida, tuttavia, di complesse problematiche sia organizzative sia di garanzia professionale degli insegnanti di sostegno.
Durante gli ultimi quindici-vent’anni il carattere inclusivo della scuola ha trovato un altro fronte di messa alla prova nella crescita esponenziale di alunni extracomunitari. Un fenomeno con dalla sua motivi d’indubbia ricchezza, perché abitua sin da piccoli alla convivenza in un mondo plurale, ma bisognoso, fra l’altro, di idonee competenze didattico-professionali degli insegnanti per un’efficace integrazione.
Ricordiamo, inoltre, che la declinazione dell’idea democratica in rapporto al sistema d’istruzione, nell’ultimo scorcio del Novecento ha avuto nel concetto di autonomia un nodo teorico-pratico di forte riferimento (cfr. legge 59/1997, Dpr 275/1999). Rispondeva al convincimento per il quale una matura democrazia scolastica andava coniugata con il principio di responsabilità funzionale, gestionale, didattica da parte dei singoli istituti, dei loro dirigenti e insegnanti. Altrettanto significativa per il nostro discorso la legge 62/2000 sulla parità scolastica (riconoscimento di equipollenza giuridica fra scuole statali e paritarie), che poneva contorni costituzionalmente definiti a un problema fonte di perenni discordie nel paese.
Una scuola di tutti e per ciascuno
Al punto in cui siamo giunti, possiamo ribadire che di strada ne è stata compiuta per democratizzare, secondo Costituzione, il nostro sistema d’istruzione. Si tratta però di un processo aperto alle sempre nuove consapevolezze ed esigenze del divenire storico. Alcune riforme dei decenni scorsi (su tutte, ripeto, la scuola media unica) costituiscono tappe miliari, ma non certo definitive, del cammino di democrazia scolastica. Basti pensare alla necessità crescente, anche a seguito dell’impetuoso sviluppo scientifico-tecnologico e culturale, di ampliare – come, del resto, si è fatto – gli otto anni d’istruzione obbligatoria fissati dalla Carta costituzionale.
Queste considerazioni relative al contesto italiano assumono maggiore profondità se traguardate in rapporto alle dinamiche internazionali delle politiche scolastiche. A tale proposito, non si possono ignorare gli effetti della svolta neoliberista fra gli anni Ottanta e Novanta in Occidente (citiamo solo i casi degli Stati Uniti sotto la presidenza Reagan, 1981-89, e della Gran Bretagna, con primo ministro Margaret Thatcher, 1979-90), gravide di ripercussioni anche sul welfare dell’istruzione. Gli esiti sono noti: distacco sempre più netto da una visione centralizzata del sistema scolastico a vantaggio di una riorganizzazione decentrata; riduzione della spesa pubblica per la scuola e incoraggiamento alla sua privatizzazione; sviluppo dell’istruzione secondo logiche di competizione/efficienza proprie del mercato; disimpegno rispetto alla riduzione delle disuguaglianze di opportunità educative; enfasi sugli standard di qualità per studenti e docenti, ma considerati in termini di risultati estrinseci e misurabili. In quest’ottica, il “destino” scolastico del giovane era affidato alle condizioni socio-economiche della famiglia di provenienza, prima ancora che alle sue capacità. Analogie con siffatta visione le abbiamo sperimentate anche in Italia, dagli anni Novanta in poi, nelle politiche dei governi di centrodestra. Ne è emerso un modello scolastico dove cultura pragmatico-funzionalistica, spirito “aziendalistico”, accondiscendenza a logiche “mercatistiche”, unitamente ad aperture di decentramento in chiave localistica, sono sembrate avere la meglio. Ricordiamo che, in quel periodo, spinte “privatistiche” e consentanee alle dinamiche proprie del “mercato scolastico”, secondo la formula «più società, meno Stato», con interpretazioni rigide dello stesso principio di sussidiarietà, sono venute pure da settori cattolici. Di fatto le politiche neoliberiste dell’istruzione hanno consolidato la storica divaricazione fra “canali nobili” e “meno nobili” degli indirizzi di studio, a pro dei primi e del loro “elitarismo”. Per quanto concerne l’Italia, permane nell’opinione diffusa sulla secondaria di secondo grado una visione gerarchizzata, che vede al primo posto i licei (classico e scientifico al vertice) seguiti dagli istituti tecnici e da quelli professionali. Nella scelta degli uni o degli altri incidono, senza dubbio, il curriculum scolastico dell’alunno, i suoi interessi culturali e le propensioni attitudinali, ma anche (e in maniera notevole) le condizioni familiari. Sicché la tipologia della popolazione scolastica dei tre indirizzi riproduce, in buona misura, la stratificazione socio-economica del paese. Come si sa, al sistema d’istruzione statale si affiancano i corsi professionali delle Regioni: è facile immaginare il prevalente livello di appartenenza sociale dei loro allievi!
«Nessuno deve restare indietro» ci hanno ripetuto in questi anni politici di vario orientamento, con riferimento anche alla scuola. Il sospetto che l’espressione, almeno sulla bocca di alcuni, avesse un significato propagandistico, è legittimo. La controprova concreta si ha anche dall’impegno economico per il welfare dell’istruzione. Il bilancio, in proposito, di parecchi governi degli ultimi due-tre decenni è stato deludente. E sappiamo che se non s’investe in scuola, Università, ricerca, cultura, il futuro di un paese è segnato.
Molto è stato fatto – lo ribadisco – nell’Italia del dopoguerra per dare un’anima democratica al sistema d’istruzione. Molto resta da fare. Il persistente divario fra regioni rispetto a “qualità/quantità” dell’offerta formativa è noto. Nonostante lo sforzo ammirevole di numerosi dirigenti, insegnanti, operatori socio-educativi, associazioni di volontariato, amministrazioni locali, evasione e dispersione scolastica in contesti di disagio sociale, come le periferie delle grandi città, restano elevati e preoccupanti. Le problematiche ricadute sulla stessa convivenza civile di una popolazione adolescenziale e giovanile borderline sono a tutti presenti.
Il processo di democratizzazione del sistema d’istruzione necessita sì di ordinamenti, strutture, investimenti all’altezza. Ma non basta. Occorre conferire un’anima democratica al sistema, che richiede, innanzitutto, comunicazione di una cultura democratica, necessaria per far crescere cittadini democratici. Lo aveva ben compreso, già nel 1958, il ministro della P.I. Aldo Moro, con l’introduzione di «Educazione civica» nelle scuole secondarie. Questo insegnamento, per varie ragioni, non ha avuto fortuna. Nel corso del tempo si è cercato di rivitalizzarlo, aggiornandolo, sino all’attuale «Cittadinanza e Costituzione» (legge 169/2008), anch’esso – a onor del vero – mai realmente decollato e sulla cui effettiva applicazione si continua a discutere.
Per essere efficace, la suddetta cultura democratica deve assumere carattere “trasversale”, trovando, cioè, alimento nei diversi insegnamenti curricolari e negli “spazi”, legislativamente previsti, di specifico approfondimento delle questioni civico-costituzionali. Ma non tutto può arrestarsi lì. Va corroborata, infatti, da coerenti stili relazionali, pratiche di vita ed esperienze partecipative intrascolastiche.
Oggi l’agenda di una convincente prospettiva culturale democratica nella scuola non può sottrarsi alle questioni cruciali della convivenza in un contesto sempre più complesso, globalizzato, multietnico, attraversato al suo interno da ripiegamenti socio-politici in senso “identitario-sovranistico” e dall’invasione debordante della comunicazione social. Pertanto s’impongono alcune parole-chiave (Costituzione, cittadinanza, partecipazione, legalità, dialogo, inclusione, immigrazione, Europa, pace, mass-media...) intorno alle quali costruire percorsi per un valido apprendistato di democrazia.
La scuola resta “bene comune” d’inestimabile valore. Tanto più in una società come l’attuale, definita, non a torto, «della conoscenza», per l’accelerazione dei processi di sviluppo dello scibile in tutti i campi. Compete all’ambiente scolastico far sì che ciascun alunno, gradualmente, impari ad “abitare il mondo” in maniera “competente”, con consapevolezza critica, senso di responsabilità, capacità relazionale. Qui, in definitiva, si misura, insieme al valore professionale dei docenti, anche la qualità intrinseca di una scuola che intenda proporsi come democratica.
Ai padri costituenti non sfuggiva che il profilo giuridico-istituzionale della democrazia dovesse accompagnarsi a quello sostanziale.
Ciò vale pure in ordine alla realtà scolastica. L’innegabile progresso compiuto per la sua democratizzazione, che ha reso la sempre più articolata offerta d’istruzione, formalmente rivolta a tutti, richiede un continuo sforzo per renderne effettiva la possibilità di fruizione personale. In duplice senso: con idonei interventi di rinforzo del «diritto allo studio» e con una sapiente opera (educativa) di promozione democratica di ogni alunno. Del resto, la scuola di tutti fallisce nei suoi obiettivi, compreso quello qui considerato, se non è anche scuola per ciascuno.