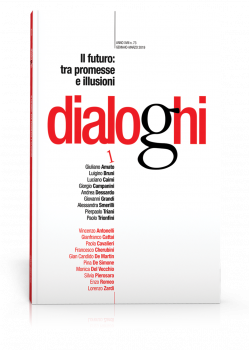L’economia di mercato nel Novecento è stata generata anche da un grande patrimonio spirituale ed etico fatto da milioni di persone educate e abituate al lavoro, capaci di fortezza e resilienza. Un’immensa energia civile cresciuta e maturata nei secoli da un terreno fecondato dalla fede vera del popolo. Negare l’idea di crescita significa mettere in crisi l’idea stessa di Occidente, e di Occidente cristiano.
Viviamo in un mondo in cui negli ultimi duecento anni sono stati compiuti progressi veloci, diverse nazioni sono uscite da stati di arretratezza di sviluppo economico, la tecnologia sta rivoluzionando l’impresa e il lavoro. Mentre guardiamo con apprezzamento i risultati raggiunti, ci chiediamo, però, se davvero viviamo nel migliore dei mondi possibili oppure se abbiamo bisogno di sguardi diversi, di nuovi modelli di sviluppo.
Un mondo dell’1%?
In un ampio studio del Fondo monetario internazionale (2013), realizzato considerando il reddito disponibile in 109 nazioni, si conclude che tra il 1990 e il 2010 le disuguaglianze interne sono cresciute in buona parte del mondo: tra i cosiddetti paesi avanzati (21 nazioni considerate), nei paesi europei emergenti (21), nei paesi asiatici (14) e nelle nazioni africane di nord-est (12). Le uniche regioni caratterizzate da una diminuzione delle disuguaglianze sono l’America Latina (19 nazioni considerate) e l’Africa sub-sahariana (22), dove tuttavia si registra un aumento di disuguaglianza per almeno un quarto delle nazioni considerate.
Nell’ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale1 si conferma il trend di crescita delle disuguaglianze e a livello di paesi si nota che nelle economie avanzate il reddito dell’1% più ricco della popolazione cresce tre volte più veloce rispetto al reddito del resto della popolazione. Muhammad Yunus, inventore del microcredito moderno, così si esprime nel suo ultimo libro: «La parola disuguaglianza è inadeguata a descrivere questa situazione, insostenibile e inaccettabile. Se voleste descrivere la differenza tra formiche ed elefanti, certamente non usereste il termine disuguaglianza!»2 . Il progresso economico porta con sé disuguaglianza, i dati dicono questo. E la disuguaglianza non porta a maggior benessere, nella maggior parte dei casi. Perché essa innesca un circolo vizioso che mina le pari opportunità per tutti. I dati dicono, per esempio, che negli Stati Uniti, dove la disuguaglianza è abbastanza alta, nel 50% dei casi il reddito dei figli è determinato da quello dei genitori ed è fortemente e positivamente correlato ad esso.
«Quando si arriva al punto in cui una sola persona possiede una parte enorme della ricchezza di un paese, che cosa può impedire a quella persona di imporre la propria volontà a tutta la nazione? Implicitamente o esplicitamente i suoi desideri diventano legge», scrive Yunus3 .
Un mondo senza risorse naturali?
La sostenibilità è oggi uno dei grandi temi dell’economia e della società. Forse il tema.
Fino a pochi anni fa il mondo della sostenibilità e quello delle povertà non si capivano facilmente e spesso si trovavano su lati opposti delle battaglie civili. Chi si occupava di difesa dell’ambiente, degli animali e delle piante, aveva linguaggio, categorie e nemici diversi da quelli delle ong e organismi che si occupavano di lotta alla povertà e alla miseria. Difendere le balene e assicurare una vita decente ai bambini del Sub-Sahara non erano obiettivi che si allineavano facilmente tra di essi.
Negli ultimi anni, invece, stiamo capendo che la sostenibilità è una sola: comportamenti ambientalmente insostenibili diventano subito povertà nuove e antiche. Nella Laudato si’ leggiamo: «Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero»4 .
Viene proposto un modello di economia circolare che consentirebbe un sistema di produzione sostenibile a contrasto di una cultura dello scarto che danneggia il pianeta e i suoi abitanti5 . Nella sua storia e tradizione la scienza economica ha sempre fatto fatica a capire la sostenibilità, e ci chiediamo il perché.
Un primo motivo è l’assenza della categoria del limite. Quando, ad esempio, in microeconomia si costruiscono le curve di indifferenza, che permettono la scelta tra i diversi beni, uno dei principi fondamentali, un cosiddetto assioma, è il principio di non sazietà (altri assiomi sono quelli di completezza, continuità e transitività)6 . Tale principio postula che, a parità di altre condizioni, un consumatore sceglierà sempre, tra due, un paniere con una maggiore quantità di beni. Avere di più è sempre meglio, questo sembra suggerire la teoria economica. È chiaro che il centesimo paio di scarpe mi darà un’utilità aggiuntiva molto minore del secondo paio, e questo è il principio dell’utilità marginale che cresce a tassi decrescenti, ma un paio in più è sempre meglio. In altre parole, l’utilità aggiuntiva derivante dal consumo di un bene non potrà mai essere negativa. Il che dunque vuol dire assenza del limite, a meno che il limite sia dato da un vincolo di bilancio, e cioè non avere risorse per potersi permettere un paio di scarpe in più. In secondo luogo, nel tempo abbiamo assistito all’eclissi della terra tra i fattori produttivi: nei primi modelli economici i fattori produttivi erano dati da terra, capitale e lavoro. Nel tempo sono rimasti solo capitale e lavoro, e la terra è scomparsa. Da unico fattore a fattore dimenticato: questa è stata la sorte della terra nella scienza economica moderna. Eppure, come ricorda la Laudato si’, se non vediamo la terra, tendiamo inevitabilmente a oltraggiarla e a distruggerla.
Inoltre, il mutuo vantaggio, il principio base della scienza economica, è stato applicato solo ai rapporti inter-umani, ma non con la terra né con altre risorse non antropiche, con le quali il rapporto non è stato concepito come reciprocità, ma come predatorio. Gli scambi di mercato vengono effettuati perché mutuamente vantaggiosi, perché ognuno ha qualcosa da guadagnare nello scambio. È anche per questo che i mercati sono così diffusi, e possono essere concepiti anche come grandi atti di cooperazione umana. Lo stesso principio, però, non si applica al rapporto con la terra, che nei calcoli economici viene solo sfruttata.
Cambiare passo
È urgente riaprire un’epoca di critica al capitalismo che abbiamo generato in questi ultimi decenni, un tempo che coincide con quello dell’era della globalizzazione e dei beni comuni. Una critica etica, culturale e prima ancora spirituale al nostro capitalismo, perché la prima insostenibilità del sistema economico-sociale che stiamo edificando in questo inizio di millennio è spirituale, in quanto stiamo esaurendo la pietas e la compassione, che sono due risorse costruite nei millenni e forse non rinnovabili. Il nostro mondo, più che ai tempi di Paolo VI, «soffre per mancanza di pensiero»7 .
Dire ciò non significa affermare che non vi siano in questi anni economisti, politologi, sociologi e filosofi che stanno offrendo critiche al nostro capitalismo, ma l’insieme delle critiche non ha ancora prodotto un’altra narrativa del nostro tempo; si arriva a proporre innovazioni importanti sia nel pensiero sia nella prassi, ma senza avere né da soli né insieme la forza di pensiero per raccontare un’economia di mercato non capitalistica. Le «capabilities» di Sen, il «social business» di Yunus, la «critica alla diseguaglianza» di Joseph Stiglitz e Thomas Piketty, l’«economia della terra» di Vandana Shiva, la «decrescita» di Serge Latouche, l’«economia della ciambella» di Kate Raworth sono fenomeni diversi tra di loro, che, se anche fossimo capaci di metterli a sistema e farli coesistere coerentemente, non avrebbero ancora creato un’alternativa a questo capitalismo; e se poi fossimo onesti dovremmo dire che ne saremmo ancora molto distanti. Pensiamo, per un esempio, alla critica di Latouche che va sotto il nome di decrescita. Certamente questa critica nel tempo dei cambiamenti climatici e dopo la Laudato si’ ha acquistato un interesse maggiore rispetto al tempo storico in cui fu formulata (fine del XX secolo). Restano comunque alcune fragilità. Innanzitutto, il paradigma dell’Occidente, inclusa la sua anima biblica e cristiana, innovando radicalmente rispetto alla visione ciclica del tempo e della storia, è stato edificato a partire da una idea di storia che tende a un eskaton, a un fine che si pone in cima a una traiettoria di sviluppo e crescita. Negare l’idea di crescita significa mettere in crisi l’idea stessa di Occidente, e di Occidente cristiano. Quindi la domanda davvero cruciale relativa al tema della crescita oggi è un’altra: crescita di che cosa, e decrescita di che cosa? Ci sono dimensioni e merci del nostro sistema economico-sociale che devono decrescere (dalla plastica all’azzardo alle armi) e altre che devono invece crescere: beni relazionali, spirituali, ambientali, beni comuni, ecc. In particolare è la dimensione economica della vita che deve decrescere (incluse le tecniche manageriali, sempre più invasive e pervasive, e i linguaggi economici utilizzati fuori dai contesti economici), e quella civile non mercantile che deve aumentare.
In particolare dobbiamo riaprire una stagione di riflessione profonda attorno alle parole povertà e ricchezza, che vengono prima di qualsiasi riflessione sulla crescita/decrescita.
Ricchezza e povertà
La nostra intera esistenza è una tensione tra il volere accumulare ricchezze che colmino l’indigenza antropologica radicale e la consapevolezza, che cresce con gli anni, che l’accumulo di merci e denaro è solo una risposta parziale, e nell’insieme insufficiente, al bisogno di ridurre le vere vulnerabilità e fragilità dalle quali proveniamo, per sconfiggere la morte. Una consapevolezza che è massima quando (e se) pensiamo a come termineremo la nostra esistenza, nudi come vi siamo venuti entrandovi, quando le ricchezze e i beni passeranno e di noi resterà – se resterà – altro.
C’è questa intuizione dietro la scelta di chi decide di diminuire denaro e merci perché scopre che la decrescita di alcune ricchezze consente la crescita di altri beni generati da quella nuova e diversa povertà scelta. Qualcosa della complessa semantica della povertà ce la dischiude l’economista iraniano Majid Rahnema, quando in una sua bella pagina distingue tra diverse forme di povertà: «Quella scelta da mia madre e da mio nonno sufi, alla stregua dei grandi poveri del misticismo persiano; quella di certi poveri del quartiere in cui ho passato i primi dodici anni della mia vita; quella delle donne e degli uomini in un mondo in via di modernizzazione, con un reddito insufficiente per seguire la corsa ai bisogni creati dalla società; quella legata alle insopportabili privazioni subite da una moltitudine di esseri umani ridotti a forme di miseria umilianti; quella, infine, rappresentata dalla miseria morale delle classi possidenti e di alcuni ambienti sociali in cui mi sono imbattuto nel corso della mia carriera professionale»8 .
Ed è qui che si apre un discorso cruciale, e troppo taciuto, sulle povertà. La povertà cattiva, quella che dovremmo presto estirpare dal pianeta, è prima di tutto un’assenza di “capitali” che impedisce la generazione di “flussi” (tra cui il lavoro e il suo buon reddito), che ci consentono poi di svolgere attività fondamentali per vivere una vita degna, e magari bella. Se guardiamo le tante, crescenti, forme di povertà non scelta e subita nelle quali si trovano intrappolate le persone, ci accorgiamo che le situazioni di indigenza, precarietà, vulnerabilità, fragilità, insufficienza, esclusione, sono il frutto della mancanza di capitali non solo e non tanto finanziari, ma relazionali (famiglie e comunità spezzate), sanitari, tecnologici, ambientali, infrastrutturali, sociali, politici, e ancor più educativi, morali, motivazionali, spirituali; carestie di philia, di agape.
Per capire allora quale tipo di povertà sperimenta una persona che viene definita povera (perché possiede meno di uno o due dollari al giorno), sarebbe fondamentale guardare ai suoi capitali, e a se e come quei capitali diventano flussi. E a quel livello intervenire. Potremmo così scoprire – se guardiamo bene – che vivere con due dollari al giorno in un villaggio con acqua potabile, senza malaria, con una buona scolarizzazione di base, è una povertà molto diversa da quella in cui si trova chi vive con due (o anche 5) dollari al giorno, ma che questi capitali non possiede, o ne possiede di meno. Come ci sta insegnando da decenni l’economista e filosofo indiano Amartya Sen, la povertà (cattiva) consiste nel non essere nelle condizioni – anche sociali e politiche – di poter sviluppare le proprie potenzialità, che così restano incagliate in capitali troppo bassi, che impediscono che il viaggio della vita sia lungo abbastanza, non troppo accidentato e doloroso.
Crisi di capitali
Stanno aumentando le povertà “cattive” e diminuendo quelle “buone”. Ci stiamo impoverendo velocemente e male perché il deterioramento dei nostri capitali civili, educativi, relazionali, spirituali, pubblici ha superato un punto critico, innescando una reazione a catena. Il nostro è un declino capitale.
Non si dice, però, che la crisi di questi capitali cruciali per lo sviluppo economico dipende in massima parte dall’aver consumato forme di capitali più importanti (morali, civili, spirituali), quelli che hanno generato economia, industria, civiltà. L’industria e prima le culture contadine, marinare, artigiane dell’Europa sono state generate da un intero umanesimo, un processo durato secoli, millenni.
C’è un’altra forma decisiva di capitale in rapido deterioramento. L’economia di mercato nel Novecento è stata generata anche da un grande patrimonio spirituale ed etico fatto da milioni di donne e di uomini educati e abituati alla sofferenza, al travaglio del lavoro, alle carestie della vita e della storia, alle guerre, persone capaci di fortezza e di resilienza di fronte alle ferite buone e cattive. Un’immensa energia spirituale e civile che era cresciuta e maturata nei secoli da un terreno fecondato dalla pietà cristiana, dalla fede semplice ma vera del popolo, e anche dalle ideologie, che erano state spesso capaci di offrire un orizzonte più grande dell’asprezza del quotidiano. C’era anche questo “spirito” popolare dentro il nostro capitalismo buono. Il capitale spirituale della persona e quindi delle famiglie, delle comunità, delle scuole, delle imprese, è sempre stato la prima forma della ricchezza delle nazioni. Una persona, o un popolo, continua a vivere e non implode durante le crisi finché ha capitali spirituali cui attingere. Non muore finché nei tempi della notte sa andare dentro l’anima propria e del mondo e trovarci qualcosa, qualcuno, cui aggrapparsi per ricominciare.
La domanda di questo “bene”, ancora in buona parte latente e potenziale, è immensa. Ma occorre saperla rintracciare proprio nel vuoto di spiritualità che (sembra) dominare la nostra era. Siamo di fronte a un passaggio decisivo, questo sì davvero epocale: se la domanda di beni spirituali non incontrerà una nuova “offerta” da parte delle grandi e millenarie tradizioni religiose, che hanno patrimoni fecondi capaci di produrre nuovi beni spirituali donati oggi con nuovi linguaggi vitali e comprensibili, sarà il mercato a offrire e vendere spiritualità, trasformandola in merci (e lo sta già facendo: vedi i vecchi e nuovi settari cialtroni for-profit). E il rimedio sarà stato peggiore del male.
Dobbiamo investire in capitali spirituali e morali e fare una manutenzione straordinaria di quanto ci resta. Lo sapeva bene il nostro Antonio Genovesi, il cui messaggio civile di speranza per l’Italia e per l’Europa è ancora tutto da attuare: «I canali di comunicazione sono altri fisici, e altri morali. Le strade sode, facili, sicure: i fiumi, e gli scavi da traghettare; le macchine trattorie [...] sono i primi. Ma si richiede de’ canali morali. La più bella, ampia, soda strada, la via Appia, la via Valeria, se sia infestata dalla paura, dalla schiavitù, dalla rabbia, dall’avania [ingiustizia], dalla penitenza, dalla miseria, non vi vedrete pure le fiere trapassare»9 .
Possiamo discutere di quali strade, ponti e ferrovie abbiamo veramente bisogno oggi in Italia. Ma, di certo, i canali morali devono continuare a crescere.
Note
1 IMF Annual Report 2017: Promoting Inclusive Growth in http://www.imf.org/external/ pubs/ft/ar/2017/eng/index.htm.
2 M. Yunus, Un mondo a tre zeri. Come eliminare definitivamente povertà, disoccupazione e inquinamento, Feltrinelli, Milano 2018, p. 53.
3 Ivi, p. 13.
4 Francesco, lettera enciclica Laudato si’ del 24 maggio 2015, n. 22.
5 Cfr. P. Lacy, J. Rutqvist, B. Lamonica, Circular economy. Dallo spreco al valore, Egea, Milano 2015.
6 Altri assiomi sono quelli di completezza, continuità e transitività.
7 Paolo VI, lettera enciclica Populorum progressio, 26 marzo 1967, n. 85
8 M. Ranhema, Quando la povertà diventa miseria, Einaudi, Torino 2005.
9 A. Genovesi, Lezioni di commercio, o sia di economia civile, (1765), volume II.