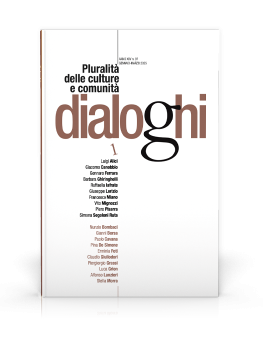Al culmine del secolo dei Lumi, Immanuel Kant, nell’operetta Risposta alla domanda: “Che cos’è l’Illuminismo?”, in forma lapidaria scriveva, tra l’altro: «Illuminismo è uscire dallo stato di minorità. Sapere aude: abbi il coraggio di usare della tua propria intelligenza». Sembrava la delineazione di un programma di valorizzazione del soggetto, che supponeva tuttavia la capacità dello stesso di raggiungere verità, anche solo di ordine morale, condivisibili da tutti. L’uso dell’intelligenza sarebbe servito a recuperare anche coesione sociale, dopo le frantumazioni prodotte dalla Riforma e dalle guerre di religione che avevano travagliato l’Europa. Sull’orizzonte si profilava la possibilità di creare una cultura nella quale i soggetti avrebbero potuto riconoscersi avendo riconosciuto principi morali indiscutibili perché razionalmente giustificati. Soggetto, verità, coesione sociale andavano di pari passo. Di questo sistema sembrano rimasti unicamente i soggetti, con la conseguenza di una frantumazione sociale conseguente alla dimenticanza della verità. Nelle indagini psico-socio-politiche si sprecano le espressioni per descrivere la deriva alla quale si starebbe assistendo: narcisismo, egolatria, hikikomori, violenza verbale e non, aumento dell’aggressività, identificazione di bisogni e diritti, ritorno massivo dell’uso del termine “nazione”, erezione di barriere difensive (personali e collettive), perdita del senso del bene comune...
L’interrogativo che si pone è se ci possa essere una via di uscita che permetta di coniugare coesione sociale e riconoscimento della pluralità di soggetti, nonché di culture, che sono l’humus entro il quale i soggetti si sviluppano e si interpretano. Pare che la tentazione seducente sia quella di tornare a forme di vita sociale guidate da leader sicuri, capaci di ricostruire il tessuto ormai lacero delle comunità, chiedendo ai cittadini di fidarsi, eliminando ogni alterità che potrebbe inquinare la cultura di una nazione, mostrando che le forme democratiche sviluppatesi in Occidente non hanno mantenuto le promesse. La tentazione è tanto più forte quanto più profondo è il disagio che le persone sperimentano trovandosi senza punti di riferimento sicuri. A questo riguardo, pare si possa riconoscere che i “padroni” della comunicazione abbiano come obiettivo avallare e alimentare un protagonismo dei soggetti per renderli maggiormente manipolabili a fini economici e, alla fine, politici: la debolezza di coesione sociale e culturale costituisce il terreno su cui i “nuovi poteri forti” riescono a diventare dominatori.
Su questo sfondo le comunità cristiane che esperienza vivono e quale contributo potrebbero offrire alla vita sociale? È davanti agli occhi di tutti la ricaduta dei fenomeni allusivamente richiamati sulla vita delle comunità: i fedeli cristiani abitano il mondo e non possono non subire l’influsso dei processi in atto. Non meraviglia pertanto constatare la privatizzazione della fede, la difficoltà a trovare persone disposte a condividere l’esperienza della comunione ecclesiale, il ritorno del clericalismo, la polarizzazione delle visioni, la contrapposizione quasi partitica delle concezioni di Chiesa, lo scarso senso di appartenenza alla comunità parrocchiale, la ricerca di oasi di comunione più psichica che pneumatica, la difficoltà di funzionamento dei cosiddetti organismi di comunione ecclesiale (consigli pastorali, presbiterali, degli affari economici). Si riscontra una specie di paradosso: la comunità cristiana, che è stata nel corso dei secoli e dovrebbe essere soggetto di coesione anche sociale, anziché costituire l'antidoto alla dissoluzione dei legami sociali, subisce gli effetti di dinamiche che potrebbe/dovrebbe correggere. Va da sé che immaginare di riproporre percorsi che sono stati efficaci nei secoli scorsi, che vedevano le comunità cristiane e più in generale la Chiesa soggetti culturali, appare illusorio. Si pone però il problema del senso della Chiesa nell’attuale stagione. I fedeli, almeno quelli che continuano a frequentare la celebrazione eucaristica, confessano lo stesso credo (peraltro andrebbe ricordato che la formula originaria del Simbolo niceno-costantinopolitano in uso nelle celebrazioni non inizia con “credo”, bensì con “crediamo”), ma, per usare un’antica espressione di Karl Rahner, il “catechismo della mente e del cuore” non corrisponde alle formule che si usano: le recenti indagini sulla fede degli italiani lo attestano. Tornare al criterio di autorità, come alcuni vorrebbero (salvo poi decidere quale autorità dovrebbe essere ascoltata: è noto che papa Francesco è oggetto di contestazione da parte di gruppi consistenti all’interno della Chiesa)? Qualora si intraprendesse questa via, ci si troverebbe nella stessa situazione di chi vede nel populismo la soluzione della crisi delle democrazie. Negli ultimi anni papa Francesco ha voluto che non fosse questo il percorso da assumere: la valorizzazione del Sinodo e la trasformazione della figura dello stesso ha fatto chiaramente capire che è possibile e doveroso convergere su orientamenti condivisi grazie alla “conversazione spirituale”. L’espressione allude all’azione dello Spirito, che è capace di creare e mantenere comunione tra i fedeli pur nella diversità di culture, sensibilità, carismi e ministeri. In questo modo si è come riscoperto il senso originario dell’aggettivo “cattolico”, che nella tradizione successiva alla Riforma aveva assunto una connotazione confessionale e, alla fine, culturale, con il rischio di identificare unità con uniformità. Questa prospettiva non è da demonizzare: i legami sociali hanno bisogno di linguaggi (non solo verbali) condivisi; una comunione puramente spirituale diventa sfuggente: per questo, per garantire l’unità, si insisteva sulla condivisione della dottrina garantita dall’autorità, della lingua (latina, almeno in Occidente), delle forme rituali. La consapevolezza che i soggetti (personali e collettivi) sono abitati dallo Spirito, che le culture, luoghi generativi di figure diverse di cristianesimo, vanno riconosciute nella loro originalità, che la tradizione cristiana è meno uniforme rispetto a quanto in genere si pensa (la molteplicità di riti e di teologie lo sta ad attestare), ha portato a riconsiderare l’unità in forma plurale. Del resto, già il fatto di avere un Vangelo quadriforme – in dipendenza non solo degli autori, ma pure dei contesti culturali e quindi dei destinatari – denota che esso può dirsi in forme molteplici. Queste nascono dall’incontro tra il medesimo Vangelo e le culture. Sicché la cattolicità della Chiesa va compresa non semplicemente in senso geografico (universale, cioè diffusa su tutta la Terra), ma pure in senso qualitativo. Lumen gentium, 13 lo ha ricordato in forma chiara scrivendo: «In tutte [...] le nazioni della terra è radicato un solo popolo di Dio, poiché di mezzo a tutte le stirpi egli prende i cittadini del suo regno non terreno ma celeste. E infatti tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in comunione con gli altri nello Spirito Santo, e così “chi sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra”. Siccome dunque il regno di Cristo non è di questo mondo (cfr. Gv 18,36), la Chiesa, cioè il popolo di Dio, introducendo questo regno nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le ricchezze, le risorse e le forme di vita dei popoli in ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica, le consolida ed eleva. Essa si ricorda infatti di dover far opera di raccolta con quel Re, al quale sono state date in eredità le genti (cfr. Sal 2,8), e nella cui città queste portano i loro doni e offerte (cfr. Sal 71 – 72),10; Is 60,4-7). Questo carattere di universalità, che adorna e distingue il popolo di Dio è dono dello stesso Signore, e con esso la Chiesa cattolica efficacemente e senza soste tende a ricapitolare tutta l’umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo capo, nell’unità dello Spirito di lui». Tenendo sullo sfondo questo testo si capisce la figura che il Sinodo, soprattutto nella modalità vista negli ultimi anni, ha assunto. Non si perde l’unità nella fede – e nei costumi – ma se ne coglie la ricchezza inesauribile. A questo riguardo si potrebbe riprendere l’immagine del poliedro usata da papa Francesco in Evangelii gaudium, 236: «Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro progetti e le loro proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori, hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto. È l’unione dei popoli che, nell’ordine universale, conservano la loro peculiarità; è la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente incorpora tutti». Prospettiva ardua, ma quella maggiormente corrispondente alla realtà, anche alla realtà plurale della Chiesa attestata dal Nuovo Testamento, dal quale si impara che le comunità cristiane si riconoscevano unite nella stessa fede (Vangelo) pur nelle forme organizzative e linguistiche diverse.
Assumere tale prospettiva e farla valere nell’attuale condizione del mondo significa non solo farsi condurre dallo Spirito, che crea unità e diversità allo stesso tempo, ma pure offrire un servizio alla società: coniugare unità e diversità è sfida e compito che le comunità cristiane fanno propri per aiutare anche i popoli a sentirsi parte della medesima umanità.
Negli articoli che compongono questo dossier e approfondiscono la problematica delineata, Piero Pisarra riflette sul nesso tra individualismo e massificazione e su come l’“individuo di massa” nel tentativo di esprimere la propria singolarità, è modellato totalmente da quella cultura dominante e massificante a cui tenta di sfuggire. Giuseppe Lorizio analizza il fenomeno della soggettivazione della fede nel tempo della post-verità, approfondendo due fondamentali nuclei tematici: il nesso verità-libertà e il nesso verità-carità. Vito Mignozzi considera il dinamismo unità-pluralità nelle comunità cristiane e nella Chiesa e sottolinea che l’unità di elementi condivisi non spinge all’omologazione ma valorizza la pluralità nella prospettiva di una Chiesa realmente sinodale. Simona Segoloni mette in luce il dinamismo relazionale che intercorre fra cattolicità (la capacità della Chiesa di incarnarsi in ogni contesto superando ogni tentazione di uniformità) e unità (l’essere una nella comunione). Luigi Alici scandaglia il nesso tra comunione ecclesiale e legami sociali, e sottolinea il ruolo possibile di una comunità cristiana capace di favorire un incontro tra l’eccedenza della comunione e le fatiche della socialità. Il Forum con gli interventi di Gennaro Ferrara, Barbara Ghiringhelli, Raffaella Iafrate si interroga ulteriormente sul rapporto tra pluralismo culturale ed elementi costitutivi della comunità cristiana, che è soggetta sicuramente alle influenze problematiche di una cultura dominante segnata da assolutizzazioni soggettivistiche ma è anche capace di essere un esempio fondamentale di incontro tra pluralità e unità, partendo dall’esperienza viva dell’incontro tra pluralità delle culture e unità della fede.