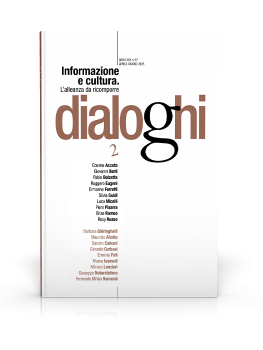Ogni giorno, mentre scorrono sui nostri schermi migliaia di notizie, video e post, è sempre più evidente il divario tra l’informazione mainstream e i saperi – scientifico, tecnico, artistico e letterario – che alimentano la cosiddetta industria culturale. L’informazione punta all’impatto immediato e si trasforma in spettacolo per attrarre click e visualizzazioni, privilegiando l’emozione rispetto al pensiero critico e alla riflessione analitica. La cultura in senso stretto è invece spinta ai margini, relegata alle ultime pagine dei giornali, confinata in ambienti specialistici. E non si sa quanto incida sulla vita pubblica e orienti la coscienza collettiva. Mai come oggi abbiamo potuto disporre di contenuti, strumenti e occasioni di accesso al sapere; eppure, paradossalmente, mancano il tempo, lo spazio mentale e la profondità necessari per trasformare quel sapere in comprensione viva del mondo.
Il rapporto tra informazione e cultura non è una questione nuova. E neppure il lamento per il numero eccessivo di informazioni futili o disparate, difficili da selezionare e memorizzare, lo è. Già nell’antichità classica non mancavano i lamenti contro ciò che Seneca chiamava «la vana passione di conoscere cose superflue»: inane studium supervacua discendi1. Ma l’avvento di internet e del Web ha amplificato il problema, tanto che non pochi studiosi oggi parlano della nostra come di un’era “inflattiva”, caratterizzata dall’eccesso di dati a nostra disposizione (vedi, nel nostro dossier, il contributo di Cosimo Accoto).
Sul piano metodologico è necessario, dunque, definire e restringere il quadro in cui ci muoviamo. Se per informazione si intende ciò che dà forma, in un racconto strutturato, a un fatto o a un insieme di fatti, anche il termine “cultura” è qui da considerare nella sua accezione comune di un deposito di conoscenze sempre in crescita, in cui svolgono un ruolo fondamentale la memoria e le connessioni (o inferenze) della mente umana. Accezione comune e limitativa rispetto al significato antropologico della parola “cultura”, da intendersi come l’insieme di saperi, di credenze, di miti, di riti e di tecniche che modellano l’habitus o l’ethos sempre in formazione degli appartenenti a una comunità data. Del resto, anche per quanto riguarda il significato antropologico e sociologico, è difficile, se non impossibile, accordarsi su una definizione univoca della parola “cultura”. Già nel 1952, in uno studio pionieristico, gli antropologi americani Afred Kroeber e Clyde Kluckhohn ne avevano elencato e analizzato ben centosessantaquattro2. Centosessantaquattro interpretazioni diverse dello stesso concetto.
Al tempo di Google, però, riaffiora con maggiore insistenza la vecchia domanda: i media hanno appiattito la distinzione tra cultura alta e bassa o, al contrario, hanno contribuito a democratizzare l’accesso al sapere? Senza dimenticare che l’informazione di qualità, quando approfondisce temi complessi, disegna accuratamente il contesto storico, indaga le cause dei fatti, pone le domande scomode, usa l’arte difficile dell’umorismo e dell’ironia, compie opera di cultura.
Il buon giornalismo investigativo, l’inchiesta documentata, la narrazione contestualizzata dei fatti sono processi che non si limitano a informare, ma educano, stimolano il pensiero critico e arricchiscono il dibattito pubblico. Al contrario, quando l’informazione rinuncia alla profondità per inseguire la rapidità, quando abbandona l’analisi per la sensazione (e il sensazionalismo), viene meno uno dei principali canali attraverso cui la società elabora significati condivisi e sviluppa strumenti interpretativi della realtà.
A questo va aggiunta la lettura che Giorgio Zanchini fa nel suo ultimo saggio a proposito del giornalismo culturale: «La sfera pubblica è sempre più densa, i media sempre più partecipativi, chi produce e immette notizie anche culturali nella rete cerca il coinvolgimento dell’utente, la costruzione di comunità, la fidelizzazione dei clienti»3.
Una sfera pubblica che oggi ha come palcoscenico principale le piattaforme digitali, e in particolare i social network, che hanno portato all’estremo la compenetrazione tra informazione, intrattenimento e vita quotidiana. Se il giornalismo novecentesco diffondeva informazioni dall’alto verso il basso, oggi la comunicazione è più orizzontale e partecipativa. E soprattutto più rapida. A discapito della riflessione meditata e del pensiero critico.
È, tuttavia, necessario distinguere tra i diversi formati digitali adoperati: riassumere un concetto filosofico in un reel di pochi secondi è operazione ben diversa dalla creazione di un podcast o di un video divulgativo bene articolato. Cambiano il ritmo della narrazione, il montaggio, lo stile, ma non necessariamente la correttezza e l’efficacia dei contenuti, se il divulgatore non si pone in competizione con la cultura tradizionale, ma adatta e traduce, per così dire, il sapere scientifico, la cultura consolidata, la ricerca documentata, alle nuove modalità comunicative.
Negli ultimi anni, il panorama del web si è ulteriormente arricchito con l’irruzione dell’intelligenza artificiale. L’IA solleva interrogativi vertiginosi e antichi quanto la storia dell’umanità: «che cosa è l’uomo e qual è il suo proprium, la sua specificità?». E altri che riguardano invece i cambiamenti in atto: «come possiamo rimanere pienamente umani nell’era delle macchine intelligenti?; che dire del principio di autorità messo in crisi dalla generazione di contenuti falsi indistinguibili dai veri?». Manipolando gli algoritmi in base alle proprie attese (o alle visioni ideologiche di Musk e soci), non si rischia di amplificare stereotipi e pregiudizi da cui le nostre società hanno faticosamente tentato di liberarsi? E per f inire: «chi è responsabile di ciò che leggiamo? Che cosa rende autentico un contenuto nell’era della generazione automatica?». Domande che toccano il cuore stesso dell’esperienza culturale come spazio di libertà e discernimento.
Un esempio significativo di queste dinamiche è l’esperimento sociale Ipnocrazia condotto tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, con la pubblicazione di un libro attribuito al filosofo inesistente (ma questo lo si sarebbe scoperto dopo) Jianwei Xun. Considerata da molti opera originale e autorevole, il libro ha generato un dibattito internazionale, prima e dopo che ne fosse svelata la natura di progetto meta-narrativo nato dalla collaborazione tra intelligenza umana e artificiale. Questo esperimento ha dimostrato in modo pratico i meccanismi della costruzione sociale della verità e la facilità con cui possono essere manipolate le percezioni nell’era digitale, sollevando interrogativi profondi sulla validazione delle fonti e sull’autorevolezza nel contesto contemporaneo. Tuttavia, nonostante l’elevarsi di voci critiche che accusano di truffa o di plagio gli autori, l’operazione dimostra come invece sia possibile una produzione di contenuti, anche profondi, con la collaborazione di intelligenza umana e artificiale, a patto che quest’ultima sia strumento di quella umana e non viceversa4.
Di fronte a scenari così complessi, quali risposte elaborare? Filosofi come Luciano Floridi e Julian Nida-Rümelin, istituzioni come la Commissione Europea con la sua Digital Education Action Plan, e altri centri di ricerca interdisciplinari propongono la necessità di un nuovo umanesimo digitale: rimettere la persona umana al centro dell’ecosistema tecnologico, promuovendo una cultura digitale a misura d’uomo.
A tal proposito, è fin da subito parso sensibile a questi temi anche il neoeletto pontefice Leone XIV che, nel suo primo discorso agli operatori della comunicazione, ha affermato: «Oggi, una delle sfide più importanti è quella di promuovere una comunicazione capace di farci uscire dalla “torre di Babele” in cui talvolta ci troviamo, dalla confusione di linguaggi senza amore, spesso ideologici o faziosi». Il contributo specifico dei credenti all’ecosistema informativo può essere proprio nell’infondere speranza, dialogo e ricerca del vero. Non si tratta di creare un’alternativa, ma di animare dall’interno il flusso mediatico con un approccio rispettoso, solidale, fatto di franchezza evangelica. Continuando a citare il Papa: «la comunicazione non è solo trasmissione di informazioni, ma è creazione di una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di confronto. […] E guardando all’evoluzione tecnologica, questa missione diventa ancora più necessaria. Penso, in particolare, all’intelligenza artificiale col suo potenziale immenso, che richiede, però, responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti»5.
È in questo ampio dibattito che si inseriscono le pagine del nostro dossier sul divorzio (vero o immaginario) tra informazione e cultura. Nel primo articolo, Enzo Romeo esplora il passaggio dall’analogico al digitale, mostrando come ciò abbia trasformato profondamente l’informazione, rendendola più rapida ma spesso più povera. Fabio Bolzetta analizza poi il ruolo dei social media nell’ecosistema informativo, illustrando opportunità e rischi della disintermediazione e sottolineando l’importanza della formazione per contrastare polarizzazione delle opinioni e fake news. Ruggero Eugeni riflette su come i media abbiano demolito il concetto elitario di cultura, favorendo invece dinamiche legate all’identità e alle capacità cognitive dei singoli; il contributo di Cosimo Accoto descrive la nuova era inflattiva dei media, caratterizzata da intelligenza artificiale generativa che, scardinando i regimi di verità, richiede nuove immunità culturali. Silvia Guidi propone un approccio al giornalismo culturale cristiano che consideri i testi come soggetti viventi, al servizio di una conoscenza intesa come essere-con e capace di generare empatia e relazione. Il Forum completa il percorso raccogliendo le riflessioni nate da una esperienza di Ermanno Ferretti (docente di liceo), Rosy Russo (esperta di comunicazione) e Giovanni Berti (illustratore) sull’ambivalenza dei social media, tra rischi di banalizzazione e opportunità di accesso alla conoscenza, delineando un’epoca in cui anche la rete può diventare spazio efficace di incontro e di ricerca condivisa.
Note
1 Vedi M. Bettini, I classici nell’età dell’indiscrezione, Einaudi, Torino 1995, pp. 3-9.
2 Vedi A.L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture: a critical review of concepts and definitions, Cambridge (Mass.), Peabody museum of American archeology and ethnology, Harvard University, 1952.
3 G. Zanchini, La cultura nei media. Dalla carta stampata alla frammentazione digitale, Carocci, Roma 2024, p. 11.
4 J. Xun, Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà, Tlon, Roma 2024. È possibile approfondire la questione partendo da qui youtu.be/sazYcECy65s?si=EvjtxbL-YeIA70H5, estratto dal convegno in cui Andrea Colamedici, uno degli autori del progetto, racconta l’esperimento filosofico e il processo creativo e concettuale che ha dato vita a Jianwei Xun e alla sua opera: un progetto meta-narrativo nato dalla collaborazione tra intelligenza umana e artificiale, progettato non solo per teorizzare sulla manipolazione percettiva contemporanea, ma per manifestarla attivamente, rendendo visibili i suoi meccanismi attraverso la propria esistenza.
5 Leone XIV, Discorso agli operatori della comunicazione, 12.05.2025.