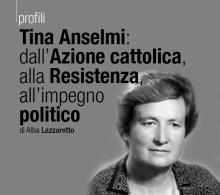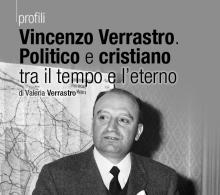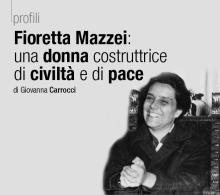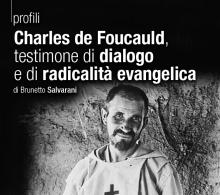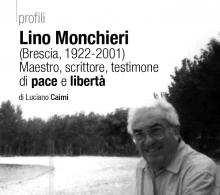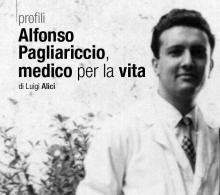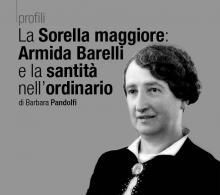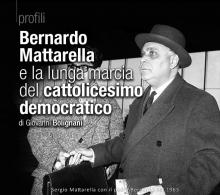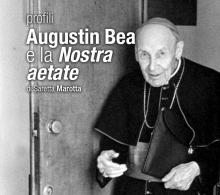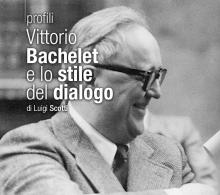Tina Anselmi: dall’Azione cattolica, alla Resistenza, all’impegno politico
«La Democrazia va conquistata, la Democrazia va vissuta e partecipata, la Democrazia va difesa»: con queste parole, che sembrano la sintesi della sua vita, Tina Anselmi teneva, il 30 marzo del 2004 (nel giorno del suo settantasettesimo compleanno) una Lectio magistralis all’Università di Trento, dopo aver ricevuto la laurea honoris causa in sociologia.