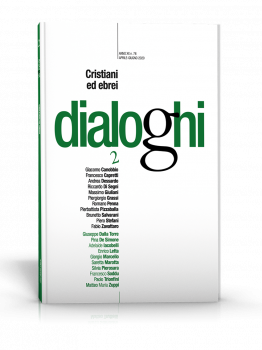La pandemia ci ha costretti a rimodulare le nostre esistenze, facendoci riscoprire fragili e vulnerabili. Chiarendoci che non si costruisce futuro rinunciando ad essere comunità incarnata nella storia, di ciascuno e di tutti. Ciò vale anche per la Chiesa. Chiamata a un nuovo passo, per seminare e fare crescere, con vicinanza e creatività, la presenza di Dio nel mondo, la nostra casa comune.
La pandemia ha colto di sorpresa tutti. È stata una tempesta non prevista e desiderata, anzi dalla quale pensavamo di essere protetti per la stolta convinzione di potere attraversare immuni il mare confuso e sempre incerto di questo mondo solo perché forti delle nostre certezze. Le varie onde del virus – da quelle iniziali che sembravano in fondo tranquille, tanto che non vennero prese in grande considerazione, a quelle che ci hanno gettato nell’angoscia, quando tutto vacillava e le nostre sicurezze affondavano, lasciandoci in balia di una forza che umiliava la nostra fragilità – ci hanno immerso nella storia, quella vera, senza sconti, senza filtri, dove si rivela chi siamo per davvero, dove occorre decidere cosa fare, perché la storia va avanti, non rispetta e non aspetta il nostro individuo, la nostra consapevolezza e le nostre scelte. L’individuo diventava spietatamente un numero, come una delle tante bare che i militari a Bergamo portavano lontano.
Quello che sembrava impensabile è avvenuto, rivelando che in realtà eravamo chiusi in un mondo immaginario, pensando di essere difesi da quelle “bolle di sapone” dove la cultura del benessere ci fa vivere, belle ma che non sono nulla, «sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza». «Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro» disse papa Francesco nel suo primo viaggio fuori dal Vaticano (papa Francesco, Omelia a Lampedusa, 8 luglio 2013). Per la pandemia dobbiamo in fondo applicare la stessa severa considerazione: «Pensavamo di potere vivere sani in un mondo malato». Credevamo che il virus riguardasse altri, i poveri oppure solo alcuni (qualcuno si era sentito sollevato perché si ammalavano “solo” i vecchi!) e invece ci ha coinvolto tutti. Così è la storia, quella vera. Pensavamo di potere vivere come volevamo, controllando tutto o quasi, prigionieri della nostra soggettività, della nostra esistenza, e ci siamo trovati noi degli oggetti, degli scarti, numeri, anonimi di una folla vulnerabile e senza nome. Ci siamo scoperti tutti malati, potenzialmente a rischio e capaci di fare del male agli altri. Appunto. Non bastava non fare nulla: era necessario pensare agli altri e difendere allo stesso tempo noi e il prossimo, proteggere e proteggerci.
Il futuro si costruisce remando insieme
La pandemia ha rivelato le difficoltà del sistema, i difetti e i ritardi, le storture e la colpevolezza di scelte non compiute in tempo, di rimandi, di sconsideratezza nel pensare al futuro condizionati dall’interesse personale e contingente. Abbiamo visto la poca capacità a lavorare assieme, ognuno difendendo le proprie forse giuste ragioni ma, appunto, non cercando l’unica ragione che è remare insieme, garantire le risposte necessarie, mettendo da parte il proprio ruolo o la propria presunzione. È stata anche la fatica istituzionale di comprendere chi doveva decidere, con altalene tra minimalismo e massimalismo, purtroppo e l’uno e l’altro dichiarati solo per convenienza, non perché vero e opportuno, per interessi di qualcuno e non di tutti. Qualche «adolescente», direbbe papa Francesco, ha faticato ad accettare le necessarie precauzioni, andando contro lo Stato che, quando funziona, è accusato di statalismo invece di essere aiutato a garantire la salute a tutti.
Una considerazione specifica dobbiamo lasciarla, con tanta amarezza e commozione, per le principali vittime di questa pandemia, che sono gli anziani, la percentuale spaventosamente maggioritaria di vittime. Quelli che dovevano essere protetti e che in realtà sono stati i più esposti. Anche in questo non permettiamo che la pandemia passi invano e moralmente dobbiamo cambiare un sistema di assistenza che uccide invece di difendere. «Siamo preoccupati dalle tristi storie delle stragi di anziani in istituto. Sta prendendo piede l’idea che sia possibile sacrificare le loro vite in favore di altre. In numerosi paesi, di fronte all’esigenza della cura, sta emergendo un modello pericoloso che privilegia una “sanità selettiva”, che considera residuale la vita degli anziani. La loro maggiore vulnerabilità, l’avanzare degli anni, le possibili altre patologie di cui sono portatori, giustificherebbero una forma di “scelta” in favore dei più giovani e dei più sani», dichiara un importante appello della Comunità di Sant’Egidio, che ha raccolto subito l’adesione di migliaia di persone. Tutte le nostre fragilità sono state rivelate dalla malattia, come una lente di ingrandimento o un reagente, ed è nostro compito sapere trarre da queste occasione di una vera conversione e di un comune impegno a ricostruire, riparando quello che si è rivelato malato o ingiusto.
Nella storia e nell’oggi, secondo la visione del Concilio
La pandemia ha colpito tutti e ha rivelato quello che siamo. Anche nella Chiesa. Ci siamo trovati come tutti e abbiamo capito che tutti erano come noi. Non è scontato, soprattutto perché non in termini astratti, ma molto concreti, fisici. Siccome abbiamo ancora la tentazione di parlarci addosso, di guardare il mondo intorno con categorie interne e non con la semplice sapienza del Vangelo, rispondiamo a domande che nessuno ci rivolge, parliamo in modo incomprensibile ai più e finiamo per fare fatica a capire quello che agita il cuore degli uomini per annunciare la gioia del Vangelo, è stato davvero importante ritrovarsi sulla stessa barca e non essere quindi distanti, alieni, risolti, ma parte della stessa avventura umana nella quale scopriamo assieme la presenza buona di Dio, alziamo lo sguardo e possiamo dare testimonianza. Abbiamo compreso nella storia e nell’oggi la visione del Concilio: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (Gaudium et spes, 1). E capendo questo grande segno dei tempi, questo kairós che ci ha reso contemporanei del nostro tempo, siamo stati costretti a dare risposte nell’oggi, ritrovando così il valore di quello che siamo, liberandoci di una logica interna e riscoprendo la creatività dello Spirito per rispondere all’ansia della creazione e delle creature che aspettano speranza e sono nelle doglie di un parto. I segni dei tempi sono indispensabili da comprendere per vivere e comunicare il Vangelo, perché in essi sono nascosti i semina Verbi. Il Vangelo parla nella storia e ci apre a questa. Il virus ha cancellato tutti gli impegni, i ruoli consolidati, le abitudini per cui potevamo cercare di fare come sempre e adesso non possiamo più dire che faremo come prima! Certo, qualcuno pensa di interpretare i disegni di Dio, anzi di usarli come verità lanciandoli a conferma delle proprie ossessioni, individuando colpevoli stanati dal castigo inequivocabile di un Dio che finalmente la smetteva con l’inaccettabile e ambigua misericordia e metteva le cose a posto. Sempre per gli altri, ovviamente.
In realtà la Chiesa, umiliata come tutti dalla tempesta, si è trovata a cambiare, così come ognuno è chiamato a convertirsi. Ci siamo tutti scoperti umili e per questo davvero forti. I sapienti di laboratorio, quelli che hanno la ricetta giusta e che non sbagliano mai, i generali di piani di conquista sempre sconfitti, di varie e differenti sensibilità, hanno iniziato ad interpretare. Il problema non è il tipo di laboratorio, ma entrare nella storia da cristiani e come Chiesa, smettendo di essere fuori dalla storia perché prigionieri di categorie astratte e soprattutto senza compiere la vera fatica che c’è chiesta: costruire comunità del Vangelo, assumersi la responsabilità pastorale di relazioni e incontri con persone e camminare fedelmente con loro. Umili perché come tutti, possiamo iniziare a parlare con tutti, stabilire contatti che erano spezzati o inesistenti, uscire per davvero perché tutti sono fuori, ritessere rapporti e servire chi era solo. Non comunità ideali o di categorie idealizzate, ma reali, di uomini e donne a cui legarsi. In realtà, quasi senza accorgercene, siamo cambiati, obbligati a parlare con tutti e tutti ci hanno ascoltato. È successo come il suono delle campane, che molte diocesi hanno sciolto in orari stabiliti per fare sentire amati e “pensati” coloro che a causa del virus erano costretti a rimanere isolati, ma non erano lasciati soli dalla preoccupazione di questa madre che non resta lontana dai propri figli. Quante iniziative digitali, a volte curiose, qualche volta ingenue, forse con qualche tentazione malcelata di protagonismo, ma tutte per restare insieme, per non accettare di essere separati. Appunto. Esattamente l'Evangelii gaudium, la sua urgenza, il rifiuto di pensarsi minoranza che vive per se stessa, che ha paura e si difende dal mondo invece di difendere il mondo dal maligno, di essere nel mondo ma libera dallo spirito del mondo, capace di parlare con tutti perché forte del Vangelo, identità che non si difende o si acquista perché ci si contrappone, ma che, proprio perché consapevole, parla ad ogni persona. La Chiesa, come una madre, non può restare lontana da coloro che cercano la gioia, che ne hanno bisogno. Siamo stati costretti a rimetterci per strada, per lo più attraverso lo strumento digitale con le deformazioni che questo può portare, ma anche con le straordinarie opportunità che garantisce. Come in una vera Pentecoste non abbiamo iniziato a parlare perché abbiamo capito tutto, perché abbiamo completato uno studio su tutte le lingue e culture che avremmo incontrato o perché avevamo il programma per convincere qualcuno; non abbiamo aspettato di risolvere i nostri problemi interni o una formula che ci eviti la passione pastorale, la fatica di avere figli da crescere. Lo Spirito, come un vento forte, ha aperto le porte e ci ha trascinato fuori, liberandoci dalle nostre paure e dall’affannosa ricerca di sicurezze previe per vincerle, donandoci una sicurezza nuova che troviamo solo “uscendo” e iniziando, diversa da quella del nostro protagonismo perché frutto dello Spirito. Se il virus divideva ed impediva la partecipazione, tanti hanno cercato i modi per restare uniti, pregare assieme, confrontarsi sui grandi temi del limite, della fragilità, del male, del futuro, della solidarietà. Quante iniziative di preghiera, dai rosari alla Liturgia delle Ore; quante celebrazioni eucaristiche sono diventate per molti appuntamenti che scandivano la giornata come mai avvenuto, appuntamenti attesi e non subiti, e diventavano una presenza importante nella difficoltà e nel disorientamento oggettivo. Tanti presbiteri e responsabili di comunità, catechisti, operatori pastorali a vario titolo e ministero, hanno cercato di raggiungere le persone nelle loro case, di regalare riflessioni, spazi, momenti spirituali. Alcuni hanno vissuto tutto questo in famiglia, ma più che la famiglia Chiesa domestica, era la Chiesa che finalmente non restava fuori dalla vita vera, dai luoghi dove questa scorre e diventava essa domestica, cioè una comunità di relazioni, un incontro di persone che permettono l’incontro con Cristo, comunione concreta, famiglia di tutti.
Anche il dialogo ecumenico e interreligioso ha avuto momenti di grande intensità. A Bologna ci siamo trovati per un momento di silenzio davanti al Comune, insieme al sindaco che rappresentava tutta la città degli uomini, insieme al rabbino e al presidente della Comunità islamica e a vari imam. Tutti hanno sottoscritto un appello ai figli di Abramo: «Come uomini di fede nel Dio unico e figli di Abramo, Padre di tutti i credenti, di fronte ai tragici avvenimenti che si stanno susseguendo in questi giorni, riflettiamo pensosi su di essi. Il nostro padre Abramo supplicò Dio di salvare gli abitanti della città. Abbiamo il dovere di pregare e supplicare Dio perché questo è ciò che Egli ci chiede! Chi salva una vita è come se avesse salvato l’intera umanità. Ci impegniamo con insistenza anche noi a invocare il Suo nome e chiediamo ai nostri fedeli, convinti che siamo tutti sulla stessa barca, di intercedere perché la vita sia preservata e possiamo tutti vedere, dopo il diluvio, il ramoscello di ulivo della vittoria sul male. Possano tutti gli uomini praticare le buone opere che aiutano gli uni e gli altri. Invochiamo Dio, Signore di pace e misericordia, che sorga presto l’arco che unisce la terra al cielo e finisca il diluvio della malattia.
Amen». Queste parole, sottoscritte prima della preghiera di intercessione di papa Francesco davanti a piazza San Pietro vuota, hanno indicato un metodo non solo per i responsabili, ma per tutti i credenti.
Vicinanza e creatività, senza vergogna
La pandemia ci ha reso umili e forse proprio per questo pieni di spirito e creativi, perché pieni di Lui e vuoti di noi. Ha scritto papa Francesco al clero di Roma parole che possiamo sentire rivolte a tutti: «Ho potuto constatare, in quei dialoghi sinceri, che la necessaria distanza non era sinonimo di ripiegamento o chiusura in sé che anestetizza, addormenta e spegne la missione». «La complessità di ciò che si doveva affrontare non tollerava ricette o risposte da manuale; richiedeva molto più di facili esortazioni o discorsi edificanti, incapaci di radicarsi e assumere consapevolmente tutto quello che la vita concreta esigeva da noi». I nostri modi abituali di relazionarci, organizzare, celebrare, pregare, convocare e persino affrontare i conflitti sono stati modificati e messi in discussione da una presenza invisibile che ha trasformato la nostra quotidianità in avversità». In questa situazione «la fede ci permette una realistica e creativa immaginazione, capace di abbandonare la logica della ripetizione, della sostituzione o della conservazione; ci invita ad instaurare un tempo sempre nuovo: il tempo del Signore» (Lettera di papa Francesco al clero di Roma, 31 maggio 2020). Queste considerazioni riguardano tutti, non solo i presbiteri. Anzi. Il ruolo dei laici è decisivo e vanno coinvolti non in astratto ma nella responsabilità vera, associandoli nell’esercizio della paternità e non del paternalismo, irritante, inaccettabile per chi lo esercita e per chi lo subisce.
Non dobbiamo chiudere sbrigativamente questa prospettiva, perché «lo zelo pastorale e la sollecitudine creativa dei sacerdoti hanno aiutato la gente a proseguire il cammino della fede e a non rimanere sola di fronte al dolore e alla paura. Questa creatività sacerdotale che ha vinto alcune, poche, espressioni “adolescenti” contro le misure dell’autorità, che ha l’obbligo di custodire la salute del popolo. La maggior parte sono stati obbedienti e creativi.
Ho ammirato lo spirito apostolico di tanti sacerdoti, che andavano con il telefono, a bussare alle porte, a suonare alle case: “Ha bisogno di qualcosa? Io le faccio la spesa…”. Mille cose. La vicinanza, la creatività, senza vergogna. Questi sacerdoti che sono rimasti accanto al loro popolo nella condivisione premurosa e quotidiana: sono stati segno della presenza consolante di Dio. Sono stati padri, non adolescenti. Purtroppo non pochi di loro sono deceduti, come anche i medici e il personale paramedico. E anche tra voi ci sono alcuni sacerdoti che sono stati malati e grazie a Dio sono guariti. In voi ringrazio tutto il clero italiano, che ha dato prova di coraggio e di amore alla gente» (Discorso a medici, infermieri, e operatori sanitari, 20 giugno 2020). Ecco cosa siamo chiamati a compiere nei prossimi mesi. Il kairós della pandemia ha allargato i nostri orizzonti, facendoci scontrare con il limite e riproponendo le domande vere della vita. Perché la Chiesa non diventi un museo.
Quello che c’è chiesto è tradurre l’esperienza in interiorità, per non perdere la consapevolezza, legata purtroppo alla situazione di emergenza, e costruire comunità, itinerari di confronto, spazi di preghiera nuovi. La tanta solitudine e le fragilità del mondo, i tanti virus ci hanno fatto scoprire come davvero il mondo è un ospedale da campo e la Chiesa non è una organizzazione umanitaria ma una madre che cerca di stare vicina ai suoi figli e li raduna, in questa condizione, per liberarli dalla tentazione di salvarsi da soli, di condannare il mondo invece di fare di tutto per salvarlo, per fare sentire la vicinanza di Dio che è in barca con noi, Gesù pastore della misericordia e della compassione per le folle che aveva sempre visto stanche e sfinite.
Evangelii gaudium. L’unica chance di futuro per la Chiesa
È la ricetta dell’Evangelii gaudium dalla quale possiamo ripartire: dal Vangelo, dalla semplicità dell’annuncio e dalla costruzione di comunità umane. È l’unica chance di futuro per la Chiesa. Quelle che abbiamo sperimentato in maniera digitale, con tanti contatti, aperte a chiunque, curate, con un linguaggio più semplice e diretto, con un senso acuto delle parole invece di ripetizioni sbiadite, senza empatia per la condizione di chi ascolta e con poco senso di emergenza. Possiamo costruire comunità esposte ai venti alle piogge e ai fiumi, ma che sappiamo non cadranno, perché fondate sulla roccia della Parola. Non comunità perfette, adulte, ma luoghi di incontro vero e personale dove accogliere e testimoniare, dove affiancarsi ai tanti pellegrini agitati da domande e tristi perché non hanno risposte. Se la Chiesa diventa domestica, cioè relazione fraterna, come siamo chiamati a fare, tutti incontreranno in un mondo di isolamento e individualismo permanente la presenza buona di Gesù. Una Chiesa domestica, familiare, potrà aiutare a costruire famiglie sul lavoro, a casa, tra le persone. In queste, non dobbiamo mai dimenticare, i poveri ne fanno parte per diritto. Abbiamo assistito a tanti episodi di attenzione al prossimo, commoventi, anzi indicati come esempio in diverse occasioni.
Questo ci deve fare scoprire i tanti doni che abbiamo e che in realtà ognuno di noi è, la necessità di comprenderli e di esserlo gli uni per gli altri. Se una comunità, una «famiglia del Vangelo», non si fa carico di qualche povero o di qualche povertà, ha tradito la sua vocazione. Sempre papa Francesco, nel giorno di Pentecoste, ci ha liberato anche da toponomastiche vecchie, esterne alla Chiesa, eppure che tanto la influenzano anche al suo interno. «Lo Spirito viene a noi, con tutte le nostre diversità e miserie, per dirci che abbiamo un solo Signore, Gesù, un solo Padre, e che per questo siamo fratelli e sorelle! Ripartiamo da qui, guardiamo la Chiesa come fa lo Spirito, non come fa il mondo. Il mondo ci vede di destra e di sinistra, con questa ideologia, con quell’altra; lo Spirito ci vede del Padre e di Gesù. Il mondo vede conservatori e progressisti; lo Spirito vede figli di Dio. Lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti; lo sguardo spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. Lo Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto: per Lui non siamo coriandoli portati dal vento, ma tessere insostituibili del suo mosaico».
Non perdiamo questa opportunità. I tre rischi, accovacciati alla porta del cuore, del narcisismo, del vittimismo e del pessimismo possono non farci cogliere il kairós, così come la fretta di trovare le risposte per non abbandonarci allo Spirito e alla sua creatività.
Misuriamoci con la solidarietà così come è avvenuto per tanti, quella concreta, senza forse grandi strutture, “della porta accanto”, possibile a tutti, per essere vicini ai più poveri, perché la carità non sia una dimensione che riguarda pochi, ma che tutti si scoprano davvero responsabili gli uni degli altri. Quante povertà! Quante fragilità portano persone vulnerabili a sofferenze inconcepibili. Quanti bambini dei quali abbiamo praticamente perso le tracce e che rischiamo restino indietro.
Il segno dei tempi della pandemia, che ci ha aperto gli occhi sui tanti virus che colpiscono il mondo (non dimentichiamo quello dello sfruttamento dell’ambiente e delle tante violenze e guerre che lo attraversano), ci aiuta a scegliere, a credere alla forza degli umili e a costruire comunità di umili e di poveri, forti del Vangelo e che da questo ripartono, nella responsabilità di tutti.
Loris Capovilla amava l’espressione Tantum aurora est. Sì, siamo chiamati alla laboriosità e generosità di ricostruire, a fare incontrare e incontrare tanti nella speranza, a leggere questo segno dei tempi perché vi sia l’inizio di un nuovo giorno e di un nuovo passo per seminare e fare crescere la presenza di Dio nella stanza del mondo, in quella casa comune che ci è affidata e che sentiamo tutta nostra.