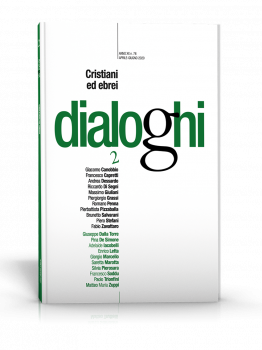"Stai lontano da me almeno un metro”. Fino ad ora questa espressione esprimeva il fastidio nei confronti dell’altro. Ora stare a un metro di distanza esprime invece l’attenzione nei confronti dell’altro, il prendersi cura di lui, volere che lui stia bene». Così ha esordito il mio viceparroco nella sua prima omelia della fase due in una chiesa che aveva finalmente ritrovato la presenza dei fedeli.
Potremmo partire da qui per interrogarci sul senso delle regole. Limitazione della libertà, disciplina imposta dall’esterno o risposta ad un’interiore esigenza di relazione?
Abbiamo a fatica accettato divieti e regolamentazioni minuziose che hanno reso ancora più faticosi e a tratti angoscianti i giorni della clausura e degli spostamenti ridotti al minimo essenziale. Lì la regola per quanto faticosa appariva immediatamente giustificata dal pericolo che si avvertiva nell’aria e che ci veniva incontro nelle immagini dei media, era resa sostenibile dalla paura che ci attanagliava dinanzi a una situazione imprevista e terribile. È stato detto degli italiani che il rispetto delle regole che li ha mostrati encomiabili ha solo confermato, se ce ne fosse stato bisogno, che il popolo del Bel Paese sa essere disciplinato se a muoverlo è la paura.
Ma d’altra parte non sorprende questa forza motivazionale della paura; e non è certamente un’eccezione. C’è anzi chi, come Hans Jonas, ha parlato del valore “euristico” della paura. La paura rispetto alle conseguenze devastanti di un’azione o di un insieme di comportamenti e di scelte è ciò che solo porterebbe ad adottare una regolamentazione dell’agire in grado di arginare atteggiamenti di rapina nei confronti della natura e di sostenere una più adeguata responsabilità nei confronti delle generazioni future, per evitare la distruzione stessa della specie umana (Il principio responsabilità, tr. it. Einaudi, Torino 1990).
Eppure la paura non basta a fondare il valore delle regole. A lungo andare, non regge. Basta che si allenti la morsa del pericolo, e subito si spalanca la porta delle eccezioni (di fatto o di diritto), delle mille giustificazioni, degli stratagemmi e delle tattiche per porsi fuori della regola, sottrarsi alla disciplina che questa impone. Non basta neppure il controllo, come pure vorrebbero in tanti, o i controllori da creare ad arte moltiplicandone la presenza e l’azione. Perché anche al controllo si può sfuggire. Senza contare poi l’annosa questione di chi debba controllare i controllori.
Non è su un sistema di divieti e di sanzioni che riesce a reggersi il valore delle regole. Prova ne sia la ripresa quasi frenetica di comportamenti e di consuetudini di vita che consentano di immaginare che nulla sia accaduto e che tutto sia tornato esattamente come era prima e come in fondo non ha mai smesso di essere.
Il fatto è che le regole per poter valere veramente non devono essere equiparabili ad una semplice prassi da adottare in vista di un fine, sia questo scelto o imposto. Ci sono regole che si giustificano all’interno di una strategia operativa e hanno perciò un carattere meramente tecnico. Ci sono regole che consentono di stare dentro un ordine, quelle che ci diamo per far funzionare meglio ciò che è comune. Kant direbbe che qui la forza della regola è tutta e interamente nel suo essere in vista di un fine particolare, qualora questo sia adottato come proprio.
Ma la funzionalità e l’efficacia non coincidono di per sé con il valore. Ciò che rende una regola veramente vincolante, incondizionatamente vincolante, fuori da ogni costrizione esterna e oltre ogni prospettiva meramente tattica o funzionale, è il valore che la regola esprime. Ed è solo allora che possiamo propriamente parlare di norma.
La norma imprime un orientamento all’agire, è criterio di scelta e di decisione. Ma la norma non è mai un fatto puramente esteriore. La sua forza è nel coinvolgimento interiore, nell’adesione che nasce dalla comprensione e dal riconoscimento del valore che esprime. Perché la norma nasce da una interpretazione delle situazioni e dalla comprensione di ciò che ci fa umani nella concretezza delle questioni che ci troviamo ad affrontare e richiede a sua volta una interpretazione, una comprensione del suo senso profondo. Armando Rigobello, un grande maestro di filosofia morale e un grande studioso del personalismo novecentesco, nel mettere in luce il nesso inscindibile che sussiste tra norma e persona, parla di un duplice movimento interpretativo richiesto dalla norma: «l’allargamento del contesto» e la «puntualizzazione applicativa». Interpretare la norma comporta che se ne ripercorra la genesi, ritrovando le ragioni che l’hanno originata, per poi restringerne l’imperatività al caso particolare, all’evento singolo. Attorno alla norma, e alla sua necessaria comprensione, si delinea così «una tensione che è rinvio al più complesso mondo interiore delle motivazioni da cui la norma è scaturita, e al più ristretto ambito situazionale a cui la norma chiede, di volta in volta, di essere applicata» (La persona come condizione ermeneutica della norma, in Persona e norma nell’esperienza morale, Japadre, L’Aquila 1982, p. 318).
La norma non è un dato assoluto, è fatta di interpretazione. E «condizione ermeneutica della norma» è il nostro essere persona. La forza della norma è nella trama di relazioni umanizzanti a cui rinvia e che essa rende possibili. La norma ha a che fare con il nucleo di significato centrale dell’essere persona: il nostro essere relazione; ed è essenziale al nostro divenire persone, che si dà unicamente attraverso la costruzione di relazioni autentiche. Diveniamo persone nella concretezza della nostra esistenza attraverso le scelte che compiamo, i comportamenti e gli atteggiamenti che assumiamo nei rapporti differenti e molteplici in cui siamo immersi. La norma sottrae le nostre scelte, e le valutazioni da cui nascono, alla fluttuazione di emozioni ed esigenze meramente pragmatiche; ci restituisce ad un ordine di senso e di valore non meramente funzionale, alla memoria di ciò che vale, al nostro essere legati gli uni agli altri, all’impossibilità di pensarci e di realizzarci veramente prescindendo dall’altro. La norma ci ricorda il valore dell’alterità e della relazione come ciò che si dà prima di tutto interiormente, perché ci costituisce in radice. Ci ricorda che non possiamo essere mai senza l’altro.
Le norme possono cambiare: non sono un’entità statica fuori del tempo e delle situazioni. Ma ciò che le rende riconoscibili e vincolanti come norme è il loro essere, per noi, memoria della presenza dell’altro nella nostra vita.
Probabilmente, quando questo numero di «Dialoghi» vi arriverà tra le mani, non ci sarà più la necessità di stare “a un metro di distanza”. Tutti noi lo speriamo e lo attendiamo con ansia. Ma rimarrà l’esigenza imprescindibile di cercare nel proprio agire e nei comportamenti quotidiani, esattamente come nelle scelte più importanti da compiere, un bene che non sia risposta ai propri bisogni del momento, ma che ci veda insieme nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno.
La pandemia ci ha insegnato che anche “a un metro di distanza” ci si può sentire una cosa sola, perché a farci comunità non è la misura dello spazio, ma la profondità della condivisione, la tenacia della cura, l’avere a cuore gli uni la sorte degli altri.
Ben vengano allora le regole, se ci aiutano a recuperare il senso profondo della norma e a liberare, con esso, il nostro desiderio di comunità.