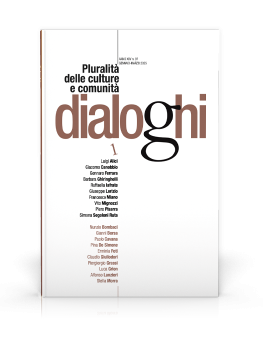La Costituzione è garanzia e strumento di promozione del pluralismo sociale e culturale. Il principio pluralista, unitamente a quello personalista e a quello solidarista, sono gli architravi dell'edificio costituzionale, della "casa comune" disegnata nell'articolo 2.
La tutela del pluralismo è un dato caratterizzante della forma di Stato contemporaneo. Nel passaggio dallo Stato monoclasse di matrice liberale, caratterizzato dal dominio di un sola classe sociale, allo Stato pluriclasse del secondo Novecento, segnato dal suffragio universale e dall’affermazione di sistemi politici pluripartitici, emerse l’esigenza di creare i presupposti per lo sviluppo di ordinamenti giuridici in grado di garantire e promuovere la convivenza di più interessi e valori, nel rispetto di alcuni principi fondamentali sui quali poter costruire più avanzati assetti politici e sociali, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini e dei gruppi sociali1 .
Lo strumento privilegiato per la realizzazione di un simile obiettivo si rivelò essere, nell’evoluzione storica, il modello di Costituzione di tipo rigido, ovvero una legge fondamentale votata da un’Assemblea costituente eletta a suffragio universale, posta al vertice delle fonti del diritto e presidiata da un organo di garanzia. In questo modo, la Costituzione cessa di essere un mero strumento per la separazione dei poteri e assume un significato assai più rilevante: quello di garanzia e strumento di promozione del pluralismo sociale e culturale.
Sul concetto di “pluralismo” occorre, peraltro, intendersi bene. In termini costituzionali il pluralismo è essenzialmente un attributo della società civile, con cui si esprime il suo spontaneo articolarsi in molteplici gruppi, associazioni, formazioni sociali, dove gli individui si organizzano per il perseguimento dei fini più vari, corrispondenti alle proprie esigenze di libertà2 . Il principio pluralista esprime, pertanto, il riconoscimento che l’ordinamento giuridico compie delle esigenze di libertà della società civile, declinate in un sistema di diritti individuali e collettivi3 . Il pluralismo non è, di per sé, un attributo dello Stato. Quando si parla di Stato pluralista si intende uno Stato che, nel suo ordinamento e nel suo assetto organizzativo e istituzionale, rispetta e riconosce il pluralismo in cui si articola la società civile4 .
Altri, invece, intendono il pluralismo come un principio o valore che troverebbe nello Stato e nel suo ordinamento la sua fonte specifica. In questa accezione normativa il pluralismo viene inteso in funzione di una più ampia partecipazione ai processi decisionali alla luce del principio di uguaglianza, convertendosi nell’esigenza di un trattamento uniforme per le varie categorie di formazioni sociali, destinate ad essere ricomprese in un processo di “integrazione pluralistica” operato a livello politico, ossia «nella finale sintesi politica operata da un organo rappresentativo, entro cui confluiscano e si ricompongano con pari dignità ed eguaglianza iniziale di chances tutte le istanze provenienti dalla pluralità sociale»5 . Ma se il referente giuridico del pluralismo diviene il principio di eguaglianza, e non quello di libertà, il problema che in relazione ad esso viene posto in primo piano è quello di un governo dall’alto della società civile per ricondurla entro i limiti fissati dallo Stato.
La Costituzione italiana e, in particolare, il processo della sua formazione in Assemblea costituente, offre un esempio paradigmatico e fecondo di convergenza su alcuni principi fondamentali in grado di guidare lo sviluppo di un ordinamento aperto all’evoluzione sociale e all’affermazione di nuovi modelli culturali emergenti dalla società civile6 .
Fin dalle prime battute dei lavori costituenti apparve chiara la volontà delle principali forze politiche, pur animate da ideologie assai diverse e contrastanti tra loro, di superare un impianto costituzionale che fosse mera derivazione dei principi rivoluzionari del 1789, ispiratori dello Stato liberale.
Nella prima seduta del 26 luglio 1946 fu Giorgio La Pira a proporre come compito della I Sottocommissione, cui spettava di delineare i principi ispiratori del nuovo Stato repubblicano, quello di «definire un sistema integrale organico dei diritti della persona e dei diritti degli enti sociali – compresi quelli economici – in cui la persona si espande. In tal modo sarà data una fisionomia della struttura sociale e giuridica della Costituzione»7 . Gli faceva eco Giuseppe Dossetti: «il tema affidato alla Sottocommissione (diritti e doveri del cittadino) sarebbe alquanto limitato se da questi diritti e doveri dovessero essere esclusi quelli di natura economico-sociale»8 . Anche Palmiro Togliatti, segretario del Pci, individuò su questo punto una prima linea di accordo: «È evidente, per esempio, che quando si tratterà di sancire i diritti del cittadino tutti si troveranno d’accordo nell’includere i principi sanciti nell’89. Ma non bisogna fermarsi a questi; occorre andare al di là di questi principi, i quali non comprendono i diritti al lavoro, al riposo, alle assicurazioni sociali, all’educazione»9 .
Emblematico di questa sostanziale intesa su alcuni principi comuni, che non eliminava certo le divergenze su altri ma poneva le basi per un dialogo che si rivelò costruttivo, fu poi il contenuto dell’o.d.g. presentato dall’on. Dossetti al termine della seduta del 9 settembre 1946. In esso, respingendo l’impostazione meramente individualista e quella totalitaria o statalista, si proponeva come «sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche» quella fondata sul duplice riconoscimento dell’anteriorità della persona umana rispetto allo Stato e sul riconoscimento dei diritti delle formazioni sociali, nelle quali si realizza la necessaria socialità delle persone mediante una reciproca solidarietà economica e sociale10. Per L’on. Togliatti esso costituiva «un ampio terreno d’intesa»11.
Il principio personalista, quello pluralista e quello solidarista divennero pertanto l’architrave del nuovo edificio costituzionale, quella “casa comune” (La Pira) che trovò la sua espressione sintetica nell’art. 2 Cost. sul riconoscimento dei «diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»12, completandosi poi nell’art. 3 Cost., che delinea il volto interventista dello Stato sociale, con una formulazione che coniuga insieme le tre qualificazioni soggettive corrispondenti alle principali matrici culturali presenti in Assemblea: il cittadino (visione liberale), la persona umana (solidarismo cristiano) e il lavoratore (socialismo e marxismo), non in opposizione tra loro ma come aspetti diversi e complementari dello stesso soggetto posto al centro dell’ordinamento.
Note
1 Sul passaggio dallo Stato monoclasse a quello pluriclasse, cfr. G. Amato, A. Barbera, Manuale di diritto pubblico. I. Diritto pubblico generale, 5ˆ ed., il Mulino, Bologna, 1997, pp. 230-231.
2 Cfr. A. Tocqueville, La democrazia in America [1835-1840], Rizzoli, Milano, 1992, pp. 523ss.
3 Cfr. C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Cedam, Padova, 1975, pp. 157-158.
4 Cfr. G. Campanini, Pluralismo, in Dizionario delle idee politiche, diretto da E. Berti e G. Campanini, Ave, Roma 1993, pp. 625ss. In termini analoghi, cfr. N. Bobbio, Pluralismo, in Dizionario di Politica, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Utet, Torino 1990, pp. 789ss., il quale peraltro distingue varie forme di pluralismo, tra cui quello socialista, quello democratico, di tipo conflittuale, e quello cristiano sociale, ritenuto di tipo organicistico. In realtà la nota caratterizzante di quest’ultimo è il principio di sussidiarietà (orizzontale), sotteso alla Costituzione italiana del 1948 e da ultimo recepito esplicitamente nel suo art. 118, ult. comma, con la riforma costituzionale del 2001.
5 F. Rimoli, Pluralismo, in Enc. Giur. Trecc., XXIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, p. 5.
6 Sul dibattito costituente e sul forte contributo progettuale apportatovi del cattolicesimo democratico, cfr. U. De Siervo, L. Elia, Costituzione e movimento cattolico, in F. Traniello, G. Campanini (dir.), Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, ½, I fatti e le idee, Marietti, Genova 1984, pp. 232ss.
7 Cfr. Camera dei Deputati – Segretariato generale (a cura di), La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, vol. VI, Commissione per la Costituzione, Roma 1970, p. 304.
8 Ibidem.
9 Ivi, p. 305.
10 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, vol. VI, Commissione per la Costituzione, cit., pp. 315ss.; ora anche in G. Dossetti, La ricerca costituente (1945-1952), a cura di A. Meloni, Bologna, 1994, pp. 101ss.; 323-324.
11 La Costituzione della Repubblica, cit., p. 323.
12 Sulla forte ispirazione solidarista della Costituzione italiana, cfr. F.P. Casavola, Struttura dello Stato e solidarietà, relazione presentata al 50° Convegno nazionale dell’U.G.C.I su “La solidarietà tra etica e diritto” (Roma, 5-8 dicembre 1998), in Iustitia, 4 (1999), pp. 385-396. Sul ruolo delle formazioni sociali nell’articolazione del principio pluralista, cfr. P. Grossi, Le comunità intermedie tra moderno e post-moderno, Marietti, Genova, 2015; E. Rossi, Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1989.