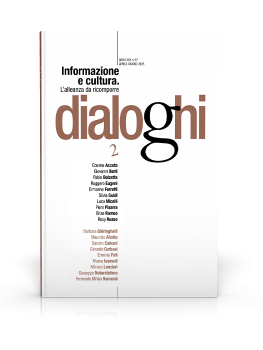Mancano ottantanove secondi a mezzanotte. Mentre scrivo, l’orologio dell’apocalisse, il Doomsday Clock, segna l’ora più buia della nostra storia. Da quando fu creato all’Università di Chicago nel 1947, due anni dopo Hiroshima e Nagasaki, il Bulletin of the Atomic Scientists indica con le sue lancette simboliche i pericoli per il pianeta: cambiamento climatico, guerre, pandemie. È buio, «tutti vanno nel buio», come nei Quartetti di T.S. Eliot: «gli uomini di stato e i governanti, / i distinti funzionari, i presidenti di molti comitati». È buio. E noi a chiederci come sia stato possibile. Pensavamo alla guerra come a un evento lontano e improbabile. La fine dei nazionalismi e l’Unione europea sembravano averci messo al riparo dal più crudele e dal più stupido dei giochi. Mai più la guerra, gridavamo nei cortei o alle marce di Assisi, mentre con il resto d’Europa riscoprivamo Erasmo, l’intellettuale dubbioso, laicamente canonizzato e divenuto il santo patrono dell’Unione. Non era stato Erasmo a dar voce al Lamento della pace e ad avere smontato, con il rigore dell’argomentazione, le “ragioni” della guerra? Già il conflitto nei Balcani aveva interrotto, con le sue atrocità, la lunga tregua dalla fine della Seconda guerra mondiale. Poi con l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia la scena è nuovamente cambiata. Anche nel resto del mondo, la retorica della forza è tornata a imporre le sue regole, anzi l’assenza di regole. Come a Gaza, dopo l’eccidio del 7 ottobre per mano di Hamas. E la vendetta di Israele, il massacro pianificato della popolazione civile, senza risparmiare le scuole, gli asili, gli ospedali. Una guerra senza fine che ora si allarga all’Iran. Trump e Netanyahu fanno un altro passo verso la guerra preventiva contro il nemico di turno, la guerra come unico mezzo di risoluzione delle controversie internazionali: il contrario di quanto stabilisce la nostra Costituzione repubblicana, all’articolo 11.
È l’ora dei cosiddetti sovranisti: commedianti mediocri recitano un copione scontato, una commedia dell’assurdo fatta di gag crudeli, di annunci reboanti smentiti il giorno dopo, con l’amico di ieri tradito e messo alla berlina davanti alle televisioni del mondo intero. Trionfano i bulli di Stato, con le loro tragiche pantomime: selfie davanti alle gabbie in cui esseri umani nati nel posto sbagliato sono esibiti come trofei di guerra; finte pubblicità immobiliari sullo sfondo di una Gaza svuotata dei suoi abitanti e ricostruita in stile Mar a Lago.
Il cattivismo programmatico, a favore di telecamera, non conosce le norme del buongusto e men che meno quelle della morale o del diritto. Ai nuovi autocrati, eufemismo oblige, bastano i like. E guai a chiamarli dittatori. I gendarmi delle parole vi mettono in guardia, prima dell’eventuale manganellata. Non si dice, non si fa. È vietato. I codici e le pandette a soccorso della neolingua orwelliana, al servizio di chi fa strame del diritto e riconosce la legittimità delle Nazioni Unite o della Corte penale internazionale a giorni alterni, secondo le convenienze.
Come sempre, la politica del più forte uccide la verità, cominciando dal diritto. Ma senza il diritto internazionale faticosamente costruito c’è soltanto il Far West, dove lo sceriffo è al di sopra di ogni legge e regna anche sul vocabolario. Scrivi fake news, leggi truth. Perché affidarsi alla diplomazia, quando bastano i muscoli tesi, i missili, la guerra?
Sulle macerie del mondo la voce di Erasmo giunge sempre più debole, il Lamento della pace sempre più inaudibile e inaudito: «chi potrebbe credere che questi uomini siano dotati di una mente razionale, visto che combattono tra loro con perenni dissidi, liti, guerre, provocano risse e scatenano tumulti? Tra rapine, sangue, flagelli e distruzione, mescolano insieme sacro e profano, e non c’è trattato inviolabile che possa dividere chi impazza nell’altrui sventura».
Ma se non quella di Erasmo, si potrebbe ancora ascoltare la voce del papa defunto: «Oggi da molte parti si reclama maggiore sicurezza», scriveva Francesco nella sua prima Esortazione apostolica nel 2013. «Ma fino a quando non si eliminano l’esclusione e l’inequità nella società e tra i diversi popoli sarà impossibile sradicare la violenza. Si accusano della violenza i poveri e le popolazioni più povere, ma senza uguaglianza di opportunità le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione» (Evangelii gaudium, 59).
Anche il nuovo pontefice Leone XIV, che fin dal primo saluto dal-la loggia di San Pietro ha posto il proprio magistero nel segno del-la pace, ha condannato con forza la follia della guerra: «La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli, che impiegano generazioni per rimarginarsi. Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, il futuro rubato» (Angelus, 22 giugno 2025). «Oggi più che mai, l’umanità grida e invoca la pace», ha aggiunto il papa. «È un grido che chiede responsabilità e ragione, e non dev’essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto. Ogni membro della comunità internazionale ha una responsabilità morale: fermare la tragedia della guerra, prima che essa diventi una voragine irreparabile».
La guerra è cambiata, ma non è meno guerra e i suoi effetti non sono meno devastanti. È una terza guerra mondiale a rate – come diceva papa Francesco –, una guerra a spezzoni e spesso per procura, combattuta da mercenari o con i droni: un crudele videogioco con un soldato-operatore che davanti a uno schermo preme il pulsante che scatenerà l’inferno a migliaia di chilometri di distanza.
Molte di queste guerre si combattono nel silenzio o nell’indifferenza dell’opinione pubblica occidentale. E le guerre lontane non interrogano più come un tempo le nostre coscienze. Poi la guerra si avvicina, si risveglia il pericolo, e noi, l’Europa, non troviamo altro rimedio che la corsa al riarmo. Nuovi missili, nuove bombe, nuovi droni. Come se un mondo senza guerra fosse il sogno di ingenui utopisti, nostalgici di un tempo che non c’è più, di quando andavamo ai concerti di Joan Baez e di Bob Dylan e il monaco poeta Thomas Merton, da un monastero del Kentucky, entusiasmava i giovani, cattolici e non, con i suoi appelli per la pace.
Con leggerezza e con scarsa memoria storica, il rifiuto assoluto della guerra è stato svalutato negli ultimi decenni in nome della real politik e dei “distinguo” tra guerre di aggressione e guerre di difesa, guerre “umanitarie” o per esportare la democrazia: basti pensare al disprezzo con cui è stata usata talvolta, anche nel linguaggio ecclesiastico, la parola “pacifismo”. Eppure nel magistero dei pontefici, da Benedetto XV, che condannò l’inutile carneficina della Prima guerra mondiale, a Francesco e a Leone, il rifiuto della guerra è una costante. E lunga, molto più lunga è la storia della nonviolenza cristiana. Dai Padri della Chiesa a Dietrich Bonhoeffer, da Thomas Merton a Ivan Illich, dai fratelli Berrigan a don Lorenzo Milani. Senza dimenticare la voce di Giorgio La Pira. «Il politico che tiene gli occhi fissi alla superficie non vede che cosa avviene nel profondo», scriveva l’ex sindaco di Firenze riferendosi al discorso di papa Montini alle Nazioni Unite del 4 ottobre 1965. «Non vede o trova irragionevole quello che ha affermato Paolo VI […] sulla pace: come, cioè, l’utopia sia destinata a divenire storia e come la storia debba, alla fine arrendersi all’utopia» (La Pira autobiografico. Pagine antologiche, Sei, Torino 1994). L’utopia della pace che anche per Erasmo è l’unica razionale e necessaria follia.