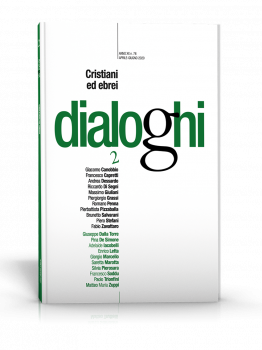Uno dei protagonisti del Concilio Vaticano II, impegnato in prima persona alla stesura della dichiarazione conciliare su “Le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane”. Un documento epocale che protesse da tentativi di diluizione, nascondimento o cancellazione che ne avrebbero ridotto o annullato la portata sostanziale. E che gli costo accuse infamanti.
La decisione di Giovanni XXIII di affidare la questione dei rapporti ebraico-cristiani al Segretariato per l’unità dei cristiani non fu dovuta a motivazioni teologiche, ovvero alla convinzione di una sua connessione con il dialogo ecumenico, quanto essenzialmente a ragioni pratiche, ovvero alla fiducia personale che il Papa nutriva nei confronti del cardinale Augustin Bea. Quando Roncalli, che fin dalla Settimana Santa del 1959 aveva voluto espungere la locuzione «perfidi ebrei» dalla preghiera universale del Venerdì Santo, incontrò il 13 giugno 1960 lo storico francese Jules Isaac, che ad Auschwitz aveva perso moglie e figli e che da tempo denunciava quell’«insegnamento del disprezzo», ovvero la dottrina tradizionale cattolica sull’ebraismo, a cui riconduceva le radici dell’antisemitismo razziale, Augustin Bea, praticamente coetaneo dei due vegliardi, solo due settimane prima era stato nominato presidente del Segretariato per l’unità dei cristiani. Confessore e consigliere di Pio XII negli anni Cinquanta, Giovanni XXIII lo aveva promosso alla porpora senza nemmeno conoscerlo, ma fin da subito si era stabilito tra i due un rapporto di fraterna stima e fiducia. Lo stesso Segretariato, organismo inedito nel panorama della Curia romana, sarebbe presto divenuto una commissione di stretta fiducia del papa, uno strumento quasi parallelo alla macchina della preparazione conciliare, da cui sarebbero provenuti i contributi più determinanti e rivoluzionari del Vaticano II. Così Roncalli ritenne che Bea fosse l’unico cardinale in grado di garantire che potesse essere affrontato con coraggio e determinazione un tema, quello degli ebrei, tanto innovativo, e radicalmente, rispetto alla Tradizione della Chiesa.
La questione ebraica da sempre era negli interessi anticotestamentari di Bea, rettore per quasi vent’anni del Pontificio Istituto Biblico e tra l’altro proprio nel periodo dell’occupazione tedesca di Roma, quando il giorno del rastrellamento del ghetto respinse il tentativo delle SS di introdursi nell’istituto, nei cui scantinati si nascondevano una mezza dozzina di ebrei. Da cittadino tedesco sentiva in modo particolare la responsabilità del genocidio, ma già negli anni Venti si era occupato più volte del tema dell’antigiudaismo cristiano, in particolare dell’accusa di deicidio. È inoltre a Bea che si deve l’enciclica del 1943 di Pio XII Divino afflante spiritu, nella quale era contenuto anche un riconoscimento dell’eredità del popolo ebraico, a cui si attribuiva «fra tutte le antiche nazioni d’Oriente un posto eminente, straordinario, nello scrivere la storia, sia per l’antichità, sia per la fedele narrazione degli avvenimenti », che per «il carisma della Divina Ispirazione e il particolare scopo religioso della storia biblica». Non è infine un caso che tra tutti i pareri pervenuti alla commissione antepreparatoria del Concilio, solo il votum del Pontificio Istituto Biblico domandasse un pronunciamento che negasse le tesi tradizionali dell’antigiudaismo cristiano.
Ricevuto da Giovanni XXIII l’incarico di occuparsi della questione il 18 settembre 1960, fin da subito il cardinale dimostrò rapidità e determinazione nell’occuparsi della questione. A fine ottobre, infatti, incontrò il presidente del World Jewish Congress Nahum Goldmann, che era pure copresidente della World Conference of Jewish Organizations, chiedendogli di tentare un coordinamento tra le miriadi di organizzazioni giudaiche per poter ricevere anche da parte loro, come dalle chiese cristiane, raccomandazioni e proposte per il Concilio; il 13 marzo dell’anno successivo, invece, col suo viaggio a New York, si consumò lo storico incontro tra un cardinale della Chiesa cattolica e diversi rappresentanti di comunità ebraiche.
Nell’agosto 1961 un primo testo sulla questione fu inviato dal Segretariato, insieme a bozze su altri temi, alla Commissione dottrinale preparatoria del Concilio presieduta da Alfredo Ottaviani. Questa rifiutò il documento, non riconoscendo all’organismo di Bea la competenza di avanzare proposte in campo teologico. Thomas Stransky, collaboratore del cardinale, ha individuato in tale rifiuto una provvidenziale «benedizione», determinante per il destino di Nostra aetate, così come di altri testi: il Segretariato modificò infatti il proprio metodo di lavoro, cominciando a preparare, con l’avallo di papa Giovanni, schemi da sottoporre direttamente al Concilio e non più pareri suggeriti all’elaborazione delle diverse commissioni.
Fu così che il 20 giugno 1962 fu presentato dal Segretariato alla commissione centrale preparatoria conciliare un organico schema sugli ebrei, la cui approvazione fu però impedita dallo scandalo che si era generato pochi giorni prima dall’annuncio del World Jewish Congress di voler inviare a Roma come “osservatore non ufficiale” al Vaticano II un consigliere del Ministero israeliano per gli Affari religiosi: tale decisione, generando l’equivoco che questi avrebbe rappresentato non una comunità religiosa, ma lo Stato di Israele, aveva provocato infatti le virulente proteste dei governi arabi del Medio Oriente. Per paura che un pronunciamento sugli ebrei potesse essere percepito come una dichiarazione politica a supporto del sionismo, fu perciò deciso che la questione ebraica fosse cancellata dall’agenda dell’imminente Concilio.
Per tutta la prima sessione Bea accettò questa provvisoria sconfitta. Tuttavia, il 13 dicembre, tornati i padri conciliari nelle proprie diocesi, il cardinale indirizzò a papa Giovanni una lettera supplicandolo a non rinunciare a ritrattare l’accusa tradizionale di «deicidio» mossa al popolo ebraico. Tale appello, subito accolto con convinzione dal papa, permise il reinserimento del tema nell’agenda della seconda sessione, decisione che venne rispettata da Paolo VI, insediatosi dopo la morte di papa Giovanni avvenuta il 3 giugno 1963. Anche Jules Isaac morì nel settembre dello stesso anno. Rimase quindi solo la tenacia di Bea a difendere il destino della futura Nostra aetate.
Anche se la sua elaborazione avvenne per mano di specialisti, non è azzardato affermare infatti che la dichiarazione sugli ebrei sia stata lo schema di Bea, con una partecipazione personale che la rende in questo peculiare rispetto agli altri documenti di competenza del Segretariato. Un esempio eloquente è il fatto che di norma un cardinale non presentasse mai in aula gli schemi elaborati dalla commissione da lui presieduta, lasciando piuttosto la parola ad altri. Tuttavia per il De Judaeis Bea fece eccezione a questa regola, riservando solo a se stesso durante le diverse sessioni la presentazione el testo, la cui materia era così di difficile recezione da parte dei padri conciliari. Proprio questa esposizione personale ha portato ad identificare la causa degli ebrei con la persona stessa di Bea, riversando sulla figura del cardinale anche gli effetti collaterali di quella macchina del fango messa presto in moto dagli oppositori del documento, non solo filoarabi ma soprattutto tradizionalisti: Bea fu accusato di appartenere alla massoneria e addirittura c’è chi rintracciò nel suo cognome presunte origini ebraiche, nel tentativo di spiegare perché il cardinale nutrisse un interesse così appassionato per una questione che ritenevano tutto sommato marginale rispetto agli altri temi conciliari.
Ma al di là degli interventi in aula, delle interviste, delle conferenze e dei viaggi, tutti mirati a convincere della legittimità di una revisione del tradizionale insegnamento della Chiesa e a garantirne la natura puramente religiosa, Bea difese la dichiarazione con passi anche più importanti e meno noti all’opinione pubblica, spendendosi, da presidente del Segretariato, per proteggere il documento da operazioni di diluizione, nascondimento o cancellazione che ne avrebbero ridotto o annullato la portata sostanziale. Durante la seconda sessione, infatti, il testo, inserito insieme al tema della libertà religiosa come uno dei due capitoli finali dello schema della futura dichiarazione Unitatis redintegratio, non venne neppure discusso, dato che in aula vennero approvati solo i primi tre capitoli relativi all’ecumenismo, mentre gli altri furono, con delusione generale, rimandati alla terza sessione. Anche se furono addotti i tempi ristretti, molti elementi fecero sospettare un vero e proprio sabotaggio ad opera degli organismi dirigenti del Concilio: non da ultimo anche il viaggio in Terra Santa di Paolo VI previsto per il gennaio 1964 incoraggiava a rimandare la questione.
Durante la preparazione della terza sessione, allo schema furono imposti da parte della Commissione centrale di coordinamento del Concilio due importanti cambiamenti: l’allargamento del testo anche ad altre religioni non cristiane, in particolare l’islamismo, e la rimozione di quella ritrattazione dell’accusa di «deicidio », che era il contenuto essenziale del documento. Questo doppio indebolimento del progetto, che ne annacquava la forza innovativa, fu coraggiosamente denunciato da Bea in aula conciliare il 25 settembre 1964, dichiarando senza mezzi termini che delle ultime modifiche non era responsabile il Segretariato. Il suo discorso davanti ai padri conciliari, che ne chiedeva l’aiuto per tornare alla versione precedente del testo, più potente e innovativa, fu molto apprezzato dall’opinione pubblica, tanto più in quanto pronunciato da un cardinale tedesco. Ma tale risonanza finì per minacciare ancora di più il documento. Il 9 ottobre 1964 fu infatti comunicato a Bea che, su indicazione del Segretario di Stato e per evitare ripercussioni politiche, era stato deciso di trattare il tema dei rapporti tra Chiesa cattolica ed ebraismo non più in una dichiarazione a sé stante, ma all’interno dello schema De Ecclesia (la futura costituzione Lumen gentium). Tale decisione equivaleva a ridurre a poche righe il testo esistente, inserendolo nello schema ecclesiologico sotto la responsabilità della Commissione dottrinale di Ottaviani. Bea protestò con vigore con Paolo VI contro questa decisione, così come contro un provvedimento analogo che riguardava il testo sulla libertà religiosa. Grazie a questo passo la minaccia rientrò e il Segretariato poté procedere autonomamente alla revisione, ampliando la parte sugli ebrei e reinserendo il riferimento al deicidio. Il documento fu finalmente votato in aula il 20 novembre 1964, ricevendo 1651 voti a favore e 99 contro, mentre 242 furono i placet iuxta modum, cioè i sì con riserva di emendamenti.
Fu un risultato vincente, ma le innumerevoli proteste nel mondo arabo rischiarono di vanificarlo: oltre agli attacchi della stampa, che gridavano alla congiura del sionismo internazionale, si aggiungevano infatti le minacce dei governi arabi di ripercussioni sulle minoranze cattoliche nei propri paesi. I patriarchi del Medio Oriente, spaventati da ciò, opposero le proteste più veementi: in particolare il patriarca dei melchiti Maximos IV si disse pronto ad abbandonare il Concilio. Tali pressioni stavano per indurre Paolo VI a rinunciare del tutto alla dichiarazione ma, scrivendogli il 26 maggio, Bea riuscì a convincerlo che sarebbe stato «vergognoso per la Chiesa e specialmente per il Concilio di cedere ad una pressione politica e si rischierebbe di nuocere gravemente alla fiducia nel Concilio e nel Santo Padre stesso, dopo che il Concilio ha approvato lo schema con una travolgente maggioranza. Il Concilio rinnegherebbe sé stesso, se ora si ritirasse». Tuttavia furono necessari dei compromessi: il testo della dichiarazione conciliare, su espressa richiesta di Paolo VI, fu modificato sensibilmente, in particolare mitigando la condanna dell’antisemitismo (con la sostituzione del forte verbo «damnat» con un più cauto «deplorat») e soprattutto eliminando ancora una volta la controversa citazione dell’accusa di «deicidio». Furono modifiche, apportate ad un testo che l’aula conciliare aveva già approvato, che crearono forte scontento, nonostante nel documento rimanesse tutta la sostanza del nuovo posizionamento della Chiesa cattolica.
Il 14 ottobre 1965 Augustin Bea compì dunque l’ultima sua fatica a favore di Nostra aetate, cercando di relativizzare davanti ai padri conciliari le modifiche introdotte e di garantire che «il tenore del testo […] [è], quanto alla sostanza, fedelmente conservato», specialmente riguardo al nodo fondamentale, ovvero l’omissione dell’espressione «deicidii rei», per la quale il cardinale sottolineò come «le difficoltà e le controversie, quasi che lo schema contraddicesse al Vangelo, di fatto provenivano soprattutto dall’uso di questa espressione», che poteva essere soppressa senza rinunciare a «ciò che nel testo anteriore volevamo esprimere con questo termine».
Lo scrutinio finale del 15 ottobre, con l’inedita cifra di 250 non placet (e 1763 placet, che comunque superarono il risultato dell’anno precedente), espresse tutta la drammaticità dell’insoddisfazione nei confronti dello schema. A questa votazione seguì, da regolamento conciliare, quella formale in seduta solenne e pubblica alla presenza del Papa il 28 ottobre 1965, quando la dichiarazione venne effettivamente promulgata: in quelle occasioni, da prassi, i padri conciliari cercavano di sostenere i testi approvati col maggiore consenso possibile. Nel caso di Nostra aetate, si ebbero 2221 voti a favore e 88 contrari, che costituivano comunque una cifra superiore ai non placet raccolti in seduta pubblica da qualsiasi altro documento conciliare.
La travagliata navigazione di Nostra aetate era dunque finalmente approdata al suo porto, dopo aver patito notevoli condizionamenti che l’avevano portata a perdere accenti importanti presenti nelle prime stesure. Anche l’allargamento del documento ad altre religioni non cristiane aveva naturalmente “annacquato” la portata del testo, ma si era trattato di compromessi ad un certo punto necessari, pur di non rinunciare a che il Vaticano II si occupasse della questione ebraica, con un pronunciamento che, come scriveva Yves Congar nel proprio diario, era ormai un’esigenza della storia perché «vent’anni dopo Auschwitz è impossibile che il Concilio non dica niente».
Se l’alto numero dei voti contrari in Concilio rimane proprio come attestazione della sua sofferta storia, esso però attesta anche la radicale novità di un documento, che si poneva come «una pietra miliare nella storia delle relazioni tra la Chiesa e il popolo ebraico», in quanto per la prima volta un Concilio ecumenico occupava in modo esplicito del problema, ponendo fine ad ogni forma di antisemitismo all’interno della cristianità.
****
Antologia
Quanto è stato detto sin qui ci permette di chiarire ancora un equivoco, in cui spesso si cade in questa materia. A volte si sente dire: Israele secondo la carne non è più il popolo di Dio, poiché lo è «Israele secondo lo spirito», ossia la Chiesa. Che cosa bisogna dire di un tale ragionamento? Naturalmente è vero che il popolo ebraico non è più il popolo di Dio nel senso di istituzione di salvezza per l’umanità. Ma la ragione non è che esso sia stato rigettato, bensì semplicemente il fatto che la sua funzione di preparare la venuta del Regno di Dio è terminata con la venuta di Gesù e la fondazione della Chiesa. D’ora in poi la natura del popolo di Dio e il modo di venir aggregati ad esso cambiano completamente: il «Popolo di Dio» del Nuovo Testamento non è più confinato ad un solo popolo, né si propaga con la discendenza carnale, bensì con la fede. Ma tutto ciò non comporta affatto la sconfessione dell’elezione di «Israele secondo la carne». Infatti «i doni di Dio e la vocazione di lui sono irrevocabili» (Rm 11,29). Israele resta carissimo a Dio per ragione dei Padri (Rm 11,28) […]. Resta inoltre il fatto che la Chiesa è stata fondata su questo popolo e su membri di questo popolo. Cristo, Capo della Chiesa, è il discendente di Abramo per eccellenza. Discendenti ne sono la sua Benedetta Madre, gli Apostoli, fondamenta della Chiesa, le prime comunità che costituirono la Chiesa. Certo la fondazione della Chiesa costituisce un decisivo nuovo inizio, dovuto tutto all’iniziativa di Gesù: è Cristo che fonda la sua Chiesa sui suoi apostoli, da lui eletti ed educati. Questo nuovo inizio si manifesta al mondo con la venuta dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Però questo nuovo inizio proviene dal popolo dell’Antica Alleanza. Gli Apostoli erano e si sentivano in tale misura ebrei, che, pur avendo già in nucleo una propria liturgia, la fractio panis e la «dottrina degli Apostoli», continuano ad andare a pregare nel Tempio e predicano per decenni tra gli Israeliti. In questo modo il popolo ebraico è e resta il buon olivo, in cui sono stati innestati gli altri popoli per diventare partecipi delle promesse divine della salvezza, fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Tutto ciò è vero e resta vero attraverso tutti i tempi e per tutta l’eternità. Inoltre anche quei membri d’Israele che non sono ancora stati aggregati al nuovo popolo di Dio, restano sempre a Dio carissimi per ragione dei Padri, e resta a loro il privilegio che il Regno di Dio e il Vangelo spettano in primo luogo ad essi: Primum Iudaeo (Rm 1,16), come ad essi sono state in primo luogo date le promesse messianiche.
(Augustin Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, Morcelliana 1966, pp. 86-90)