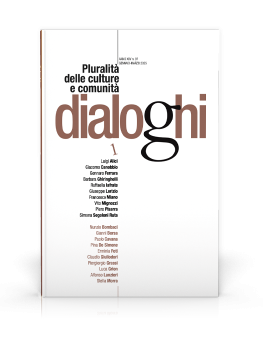Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, tra mosse radicali e sfide geopolitiche, l’Europa fragile e divisa deve affrontare un nuovo unilateralismo. Intanto, populismo e nazionalismo avanzano, minacciando libertà e diritti, mentre difendere democrazia e partecipazione diventa una sfida sempre più urgente.
Giornalisticamente non gli si sta dietro: una ne pensa, cento ne dice e troppe ne fa. Una cosa è certa: Donald Trump sa stupire, conquista media e social network, questi ultimi alimentati ad arte da entusiastici sostenitori, nonché dai soldi e dall’influenza del suo patron, Elon Musk. In una progressione stupefacente, cominciata in campagna elettorale, esplosa al momento della vittoria elettorale e decollata con l’insediamento nello Studio Ovale il 20 gennaio 2025, il presidente ha inanellato un’incredibile serie di dichiarazioni sorprendenti, decisioni equivoche, passi indietro e rilanci da vero sprinter del sovranismo targato “America First”. Trump spiazza tutti: i tradizionali alleati e gli storici “nemici” delle Stars and Stripes, la vecchia Europa e persino il Regno Unito, l’ucraino Zelensky e il cinese Xi Jinping; getta il panico tra gli immigrati “irregolari” che abitano e lavorano negli Stati Uniti e tra gli operatori umanitari di mezzo mondo.
Un gioco pericoloso
Il suo ritorno alla Casa Bianca, da molti auspicato (i tanti cittadini americani che lo hanno votato), da altri temuto (anche sulla base di ciò che “The Donald” aveva combinato nel primo quadriennio alla guida del Paese), è stato – relativamente – spiazzante considerando i toni con i quali si è ripresentato agli americani e al mondo intero nelle scorse settimane. Trump, oltre ad aver messo in discussione alcuni capisaldi dello stato di diritto sul fronte interno1 , ha lanciato varie provocazioni sul piano economico (questione dazi), politico (atteggiamento muscolare e minacce verso Canada, Panama, Groenlandia, popolo palestinese), migratorio (stavolta a farne le spese sono stati il Messico e altri Paesi latinoamericani). Circondato da diversi personaggi dubbi (il primo dei quali, appunto, l’onnipresente miliardario nazionalista Elon Musk), è intervenuto a gamba tesa sulla guerra in Ucraina, strizzando l’occhio a Putin, sul conflitto tra Israele e Hamas («faremo della Striscia di Gaza la riviera del Medio Oriente»), sui rapporti commerciali con la Cina e con l’Ue...
L’illusione che si trattasse di “fuochi artificiali” da inizio presidenza non ha trovato riscontro. Più si va avanti, più aumentano le sortite. Ogni elenco delle brutte sorprese risulterebbe incompleto: in pochi giorni Trump ha picconato il multilateralismo e il diritto internazionale, alcune benemerite istituzioni storiche come l’Organizzazione mondiale della sanità e la Corte penale internazionale dell’Aia, s’è sfilato dagli Accordi internazionali di Parigi per contrastare il cambiamento climatico, ha assegnato un colpo mortale alla solidarietà e alla cooperazione allo sviluppo, nonché ai diritti umani, tagliando i fondi a UsAid.
Proseguendo su questa strada gli Stati Uniti, anziché costituire un solido punto di riferimento sullo scacchiere planetario, assumeranno il ruolo di ingombrante player alla conquista del Risiko2 .
Europa batti un colpo
Anche l’Europa dei 27 comincia a misurarsi con la nuova era Trump3 . Gli Stati Uniti continueranno ad essere partner affidabili del vecchio continente oppure attiveranno politiche economiche, ambientali e persino militari tali da porre in discussione la lunga e reciproca amicizia tra le due sponde dell’oceano?
D’altro canto l’Unione europea si trova in una fase di debolezza. A sua volta segnata dai venti nazionalisti, deve scontare crescenti divisioni tra gli Stati membri. L’economia continentale non è in ottima salute, le forniture energetiche sono a rischio, la spesa per sostenere la difesa ucraina dall’aggressione russa sta lievitando, così come costerà cara la ricostruzione del Paese centro-orientale messo a ferro e fuoco dalle milizie di Putin. Nel frattempo gli altri player mondiali – la Cina, l’India, il Brasile... – si fanno avanti, rosicchiando terreno sotto i piedi dell’Ue.
Un’analisi in questa direzione è giunta da un conoscitore dell’Ue, degli interessi e dei limiti dell’Unione Europea, l’ex commissario italiano Paolo Gentiloni, il quale ha affermato che con il ritorno di Trump «un’onda di angosciati interrogativi attraversa l’Europa. Che cosa ci aspetta sull’Ucraina? E sui dazi? E sulle spese Nato? Converrebbe tuttavia interrogarsi anche su che cosa faremo noi, noi europei. Per l’Europa il ritorno di Trump alla Casa Bianca è infatti anche un’occasione, può essere addirittura la sveglia che ci costringe a correre»4 .
Ecco, la debole e divisa Europa è chiamata a serrare i ranghi, a immaginare le prossime mosse senza aspettare che altri – neppure gli Stati Uniti – decidano il suo futuro.
In questo senso qualche timido segnale s’è notato. La Commissione europea ha presentato il 29 gennaio la “Bussola per la competitività” (Competitiveness Compass), che, con le parole della presidente Ursula von der Leyen, «trasforma le eccellenti raccomandazioni del Rapporto Draghi in una tabella di marcia» per innovare e rafforzare l’economia e il mercato unico dell’Unione. Dal canto suo il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha raccolto i capi di Stato e di governo degli Stati aderenti in un conclave informale, tenutosi il 3 febbraio, per ragionare insieme sulle sfide che attendono l’Europa in materia di sicurezza e difesa (con un esito assai discutibile: spendere di più per armamenti e industria bellica).
Nel complesso si ravvisa nelle sedi Ue – nonostante le citate divisioni interne e l’indebolimento dell’afflato europeista in Paesi-chiave come Germania, Francia e Italia – un tentativo di tener testa agli Stati Uniti versione trumpiana. Un segnale si potrebbe rilevare dagli sforzi europei indirizzati a costruire la pace in Ucraina. Si pensi al vertice informale di Parigi del 17 febbraio, convocato dal presidente francese Macron: otto i governanti invitati (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi, oltre ai leader Ue Von der Leyen e Costa e al segretario generale della Nato, Rutte) per dare un segnale a Trump e Putin, i quali nel frattempo avviavano i colloqui di Riad, escludendo l’Europa e l’Ucraina. Il rendez-vous della capitale francese si è concluso con un sostanziale nulla di fatto, almeno sul piano delle decisioni immediate, mentre da parte di tutti è stata ribadita l’intenzione di porre fine al conflitto scatenato da Putin tre anni fa, con l’impegno ad assicurare una “pace giusta e duratura” all’Ucraina. Senza specificare a quale prezzo – e con quali concessioni alla Russia e agli Usa – stabilire il termine del conflitto.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorevolmente “dato la sveglia” proprio all’Europa con un discorso pronunciato a Marsiglia il 5 febbraio: «L’Europa intende essere oggetto nella disputa internazionale, area in cui altri esercitino la loro influenza, o, invece, divenire soggetto di politica internazionale, nell’affermazione dei valori della propria civiltà? Può accettare di essere schiacciata tra oligarchie e autocrazie? Con, al massimo, la prospettiva di un “vassallaggio felice”. L’Europa appare davanti a un bivio, divisa, come è, tra Stati più piccoli e Stati che non hanno ancora compreso di essere piccoli anch’essi, a fronte della nuova congiuntura mondiale. [...] Occorre che gli interlocutori internazionali sappiano di avere nell’Europa un saldo riferimento per politiche di pace e crescita comune. Una custode e una patrocinatrice dei diritti della persona, della democrazia, dello Stato di diritto».
Quindi un richiamo alle vaticinate, e improrogabili, riforme interne: «Le attuali istituzioni non bastano, tuttavia, e le riflessioni poste in essere dalla Conferenza sul futuro dell’Europa negli anni scorsi meritano di essere riprese e attuate, con una politica estera e di difesa comune più incisiva, capace di trasmettere fiducia nei confronti del ruolo europeo nella risposta alle sfide globali»5 .
Dalla parte della democrazia
Rimane, però, un argomento di fondo. Donald Trump non arriva da Marte. Ha ampiamente vinto le elezioni e il suo partito, i Repubblicani del Grand Old Party, s’è imposto nei due rami del Congresso a Washington (collocato a Capitol Hill, che richiama alla memoria l’assalto del 6 gennaio 2021 portato al parlamento dai suoi sostenitori, con la benedizione di Trump allora sconfitto da Joe Biden). Trump si colloca in un rapporto di causa-effetto con il populismo e il nazionalismo (accettando queste definizioni, senza soffermarci su tutte le precisazioni e le sfumature che si renderebbero doverose) che attraversano una buona parte delle democrazie occidentali, e segnatamente l’Unione europea. Un populismo – che per lo più si accompagna al nazionalismo – prodotto da una pseudo cultura imperante, dal mainstream dominante, dall’assertività tipica dei social spacciati per spazi di libero confronto, dall’individualismo diffuso, dal venir meno del senso di comunità, dall’indebolimento della solidarietà internazionale... Populismo figlio delle paure che ci attanagliano, alcune delle quali possono essere considerate un’eredità dei fenomeni generati dalla globalizzazione, ma in altra parte sono seminate ad arte per interessi politici ed elettorali: basti pensare allo stigma, dall’acre sapore razzista, riversato sulle persone e sui popoli costretti a migrazioni forzate dovute a povertà, fame, guerre, cambiamenti climatici. È in atto un profondo cambiamento di mentalità, forse antropologico, che si riversa sul modo di intendere le relazioni interpersonali e sociali; la fatica di informarsi, sapere e dialogare viene volentieri bypassata; democrazia e partecipazione appaiono noiosi impicci delegabili al leader mediaticamente più affascinante. Una conferma giunge dal generale “svuotamento” dei partiti, divenuti per lo più macchine elettorali, e dalla volubilità dei corpi elettorali, dipendenti dai sondaggi, disposti a premiare non già lungimiranti e condivisi progetti politici di lungo respiro, bensì persuasivi affabulatori dalle promesse impossibili, che poi, puntualmente, non saranno mantenute.
I successi di Trump e di tanti suoi fan ed emuli europei (i cosiddetti “patrioti”), come l’ungherese Viktor Orban, la francese Marine Le Pen, l’olandese Geert Wilders, lo spagnolo Santiago Abascal, l’austriaco Herbert Kickl, oltre alla tedesca Alice Weidel, pongono profondi interrogativi che toccano la sfera della convivenza civile, il futuro stesso delle democrazie liberali come sono state intese finora, giungendo a mettere in discussione quel (oggi possiamo ben dire “fragile”) patrimonio di valori, norme e diritti fondamentali plasmati in Europa soprattutto a partire dal secondo dopoguerra.
C’è ancora tempo per evitare il peggio. Non si può rinunciare a pace, libertà, giustizia, eguaglianza. Probabilmente occorre agire su più piani: dell’educazione e della cultura, del contrasto alla disinformazione e alle fake news, del volontariato e dell’impegno pubblico, della difesa dei valori fissati nelle costituzioni democratiche, della partecipazione responsabile al voto e alla politica. La sfida è enorme eppure irrinunciabile.
Il testo è stato consegnato in redazione il 18 febbraio 2025.
Note
1 Qualche protesta di piazza ha preso forma negli Stati Uniti, e non sono mancati commenti politici e mediatici allarmati sulle testate statunitensi. Interessante, fra l’altro, l’editoriale dell’autorevole rivista scientifica «The Lancet», dal titolo American chaos: standing up for health and medicine, vol. 405, 8 febbraio 2025 (thelancet.com), che affronta i temi della salute, del cambiamento climatico e, in generale, dei diritti minacciati dall’amministrazione Trump.
2 Le analisi sui media americani, europei e italiani sono numerosissime. Solo qualche titolo: M. Gaggi, La prova di forza, «Corriere della Sera», 21 gennaio 2025; G. Ferrari, Il Mondo nuovo di “The Donald” dovrà fare i conti con la dura realtà, «Avvenire», 22 gennaio 2025; M. Ferrera, Il rischio della via illiberale, «Corriere della Sera”, 9 febbraio 2025.
3 Su questi temi cfr. ad esempio: Il tiranno Trump disorienta l’Ue, «Il Mattinale», 9 gennaio 2025; C. Mudde, La solitudine dell’Europa nel 2025, «Voxeurop», 14 gennaio 2025, ora in «Internazionale» (internazionale.it); A. Bonanni, Questione di sovranità, «La Repubblica», 22 gennaio 2025; G. Sarcina, L’Europa disunita alla meta, «Corriere della Sera», 5 febbraio 2025.
4 P. Gentiloni, Trump e la scossa che serve all’Europa, «La Repubblica», 13 gennaio 2025.
5 Intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall’Università di Aix-Marseille: L’ordre international entre règles, coopération, compétition et nouveaux expansionnismes, Marsiglia, 5 febbraio 2025.