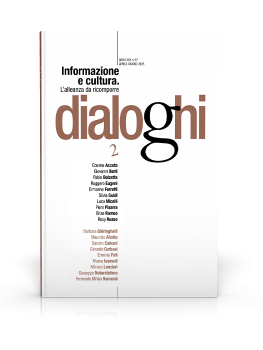Le Nuove indicazioni nazionali 2025 mostrano un preoccupante approccio prescrittivo ed eurocentrico, rischiando di compromettere la libertà didattica e trascurando temi cruciali come inclusione, multiculturalità e parità di genere, essenziali per una scuola davvero contemporanea e democratica.
L’ 11 marzo 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le Nuove indicazioni per la scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 2025, specificandone la natura di bozza in previsione di un dibattito pubblico che sta interessando la comunità educante ma non solo. Sono tantissime le associazioni che hanno espresso riserve o approvazione; tuttavia, i comunicati in circolazione sono rimasti spesso in superficie, anche perché il Ministero ha dato l’opportunità di esprimere osservazioni con tempistiche inadeguate affinché vi potesse essere una lettura approfondita del testo – che è di 153 pagine – e una condivisione democratica e collettiva all’interno delle associazioni chiamate in causa.
Ma facciamo un passo indietro: quando parliamo di Indicazioni nazionali, facciamo riferimento a una non così nuova concezione della scuola, secondo la quale non esistono più i programmi disciplinari, per cui è obbligatorio trattare certi autori, certi temi ecc., ma appunto delle indicazioni, delle linee guida che permettono al docente quella maggiore flessibilità che è stata immaginata quando, nel 1999, si è passati all’autonomia scolastica.
Le indicazioni del 2012 e quelle del 2025, un esempio
Fatta questa premessa, è da ricordare che c’erano già state delle Indicazioni nazionali nel 2012, perciò è bene interrogarci sulla necessità di un nuovo documento, soprattutto con un così breve tempo di restituzione collettiva.
Il testo precedente – di sole 68 pagine – sembrava aderire meglio all’idea di indicazioni, poiché forniva delle indicazioni, appunto, sul lavoro del docente. Un esempio tra tutti è quello sulla centralità della lettura come opportunità di «socializzazione e di discussione dell’apprendimento di contenuti, ma anche come momento di ricerca autonoma e individuale, in grado di sviluppare la capacità di concentrazione e di riflessione critica»1. In questo caso l’indicazione è valida perché lascia pieno margine all’insegnante di valorizzare il processo di lettura. Nel nuovo testo, invece, leggiamo: «Leggere testi che contengono idee intelligenti aiuta chi li legge a diventare intelligente a sua volta […]. Vale a dire che la letteratura – e solo la letteratura – è sia un modo per conoscersi, trovando nei pensieri, nelle emozioni e nei desideri che gli scrittori del passato hanno saputo tradurre in parole la traccia di un’umanità comune (e quindi anche per non sentirsi soli nel proprio percorso di crescita), sia un modo per imparare a stare nel mondo con consapevolezza, cioè per stabilire relazioni significative, di collaborazione, rispetto, fraternità, con coloro che ci circondano»2. Qui pare evidente il ruolo ancillare dei testi non letterari a scapito di quelli letterari, come se solo attraverso questi ultimi si potesse davvero formare la coscienza critica dei nostri alunni e delle nostre alunne. Sorgono poi domande a cui è difficile controbattere: è davvero così importante studiare letteratura al primo ciclo? È proprio vero che per definirsi civili è cruciale conoscere la letteratura? È “solo” la letteratura uno strumento per riconoscerci in “un’umanità comune”, “per imparare a stare nel mondo con consapevolezza”? La risposta non può che essere un sonoro no.
In generale, quindi, la critica più evidente è legata all’utilità di queste Nuove indicazioni: se ce ne fosse stato bisogno, sarebbe stato per inquadrare meglio le sfide a cui oggi la scuola è chiamata a dare risposte e che nel 2012 forse emergevano con meno chiarezza: la multiculturalità, le tematiche relative alla parità di genere, all’insegnamento dell’affettività, l’inclusione ecc. Tutti aspetti che invece non sono stati ritenuti centrali per la scuola del XXI secolo.
La nuova visione della scuola: una riflessione generale e una sulla parte introduttiva
Da questo breve confronto emerge come le nuove indicazioni abbiano un’impostazione ideologica ben evidente, che lederebbe il principio della libertà dell’insegnamento. Lo si nota sia nella parte introduttiva sia nella parte più specificamente legata alle discipline insegnate.
Innanzitutto va precisato che la natura di bozza emerge chiaramente perché la struttura del testo risulta ostica, forte punto a sfavore, essendo questo un testo destinato alla consultazione, anche ripetuta nel corso del tempo.
A questo si aggiunge, in modo talvolta sottile talvolta esplicito, un’impostazione prescrittiva, che si nota a partire dall’introduzione delle Indicazioni. Emerge senza troppi giri di parole una visione eurocentrica, talvolta classista, spesso polarizzata, che non vogliamo che sia la rappresentazione della scuola italiana: leggiamo, ad esempio, che «la libertà è il valore caratteristico più importante dell’Occidente […]. Capire che cosa è la libertà e soprattutto cosa significhi essere liberi (anche attraverso il confronto con coloro che liberi non sono, in moltissime parti del mondo), agevola la comprensione di cosa sia una democrazia occidentale e le connessioni esistenti fra quest’ultima e il sistema dei diritti e dei doveri di cittadinanza conquistati dall’Europa, anche al prezzo di guerre terribili»3. Questo modo di scrivere – per chi ha una classe con tanti allievi e allieve con background migratorio – non può essere accolto, perché sottende a una visione gerarchica in cui acquista un valore positivo solo l’Occidente, Occidente a cui il resto del mondo deve guardare per imparare.
O ancora, parlare della violenza di genere come di una «patologia»4 significa non riconoscere la condizione strutturale della nostra società che legittima la superiorità del maschio bianco occidentale, relegando la violenza a forme di deviazione dalla norma, come se gli innumerevoli casi di cronaca non smentissero quasi quotidianamente questa – dura a morire – percezione.
Nel dettaglio: alcuni stralci delle Indicazioni relativamente alle discipline umanistiche
Questa impressione di ideologizzazione e prescrittività del documento aumenta in particolare per alcune discipline. Per competenza di chi scrive, ci limitiamo in questa sede alle discipline umanistiche.
Per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano, viene posta un’eccessiva importanza alla legittimazione della lingua da parte della comunità colta e del primato della scrittura sulle altre abilità da sviluppare. Un’ottica ormai anacronistica, che trascura tutto il lavoro di insegnamento dell’italiano come lingua seconda (cioè per chi non è italofono): scrivere che il primo obiettivo dell’educazione linguistica è il possesso della lingua di scolarizzazione5 significa negare alla lingua il ruolo primario di strumento di comunicazione nei contesti reali.
Il latino, poi, viene visto come una disciplina necessaria più a veicolare una certa cultura della tradizione classica6 fine a se stessa e orientata allo studio liceale, come se il focus della nostra scuola riguardasse l’irrisoria minoranza di studenti che poi scelgono effettivamente indirizzi in cui lo si studia, propugnando di fatto una visione invisibilizzante di tutte le altre proposte formative che pure i nostri istituti hanno.
E infine la storia, la disciplina su cui sono state spese più parole nel dibattito pubblico. Basti solo citare l’introduzione: «Solo l’Occidente conosce la storia»7, nel senso che ha sviluppato una tradizione storiografica e una concezione della riflessione storica che non esiste in altre culture. Questa è un’affermazione forte, che tuttavia richiede che persone con ben altre competenze rispetto a quelle di un docente comune, formato comunque in prospettiva eurocentrica, smentiscano. E se anche fosse vera, non è opportuno sostenere che una certa visione della storia, per come si è sviluppata in Occidente e nella tradizione giudaico-cristiana (altro fortissimo riferimento di queste pagine), sia necessariamente l’unica visione della storia o la sola corretta.
Conclusioni
Ci auguriamo dunque che il Ministero, viste le numerose riflessioni che come comunità educante stiamo ponendo, ascolti con attenzione e risponda con sollecitudine: allora sì che le Nuove indicazioni saranno frutto di un lavoro collettivo, trasversale e rispettoso del lavoro che svolgiamo mettendoci a servizio delle nostre studentesse e dei nostri studenti.
* Il testo è stato consegnato in redazione il 15 maggio 2025, prima della pubblicazione delle Linee guida definitive.
Note
1 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, p. 28. mim.gov.it/ documents/20182/51310/DM+254_2012.pdf (u.c. 03.06.2025).
2 Ivi, p. 36.
3 Ivi, p. 10.
4 Ivi, p. 11.
5 Ivi, p. 36.
6 Il fatto stesso che si leggano frasi come la seguente: «… provenienze non solo dal latino ma anche dall’arabo, da altre lingue moderne europee, da lingue esotiche» ci fa capire come ciò che è altro dalla cultura occidentale – quale che sia la definizione di occidentale – non ha valore in sé, perciò è lecito utilizzare definizioni che sono frutto di una visione chiusa all’alterità, alla differenza, al dialogo con ciò che non conosciamo e quindi giudichiamo sommariamente.
7 Nuove indicazioni per la scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 2025, p. 68. mim.gov.it/documents/20182/0/Nuove+indicazioni+2025.pdf/cebce5de-1e1d-12de-8252-79 758c00a50b?version=1.0&t=1741684578272 (u.c. 03.06.2025).