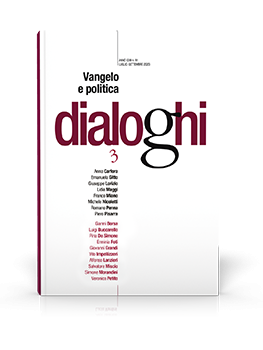The last of us, serie tv rilasciata da HBO nel gennaio del 2023, è stata una delle più seguite di quest’anno. Proiettati in un mondo dai tratti apocalittici, la serie spinge a riflettere su alcune delle questioni più scottanti degli ultimi anni. In tale contesto, le scelte dei vari personaggi mostrano un variegato campionario umano, tra chi cede alla brutalità e chi custodisce il senso dell’umano.
Un buon prodotto di intrattenimento deve avere la capacità di attrarre il fruitore. In quelle prime pagine, in quei minuti iniziali, un libro, un film o una serie si giocano l’attenzione del pubblico, perciò è bene prestare particolare cura a come un qualcosa inizia, perché è dal suo inizio che potrebbe generarsi la prosecuzione della visione, e con la prosecuzione il passaparola, e la magia di potersi raccontare a tante persone, anche a distanza di tempo.
Certo, un inizio coinvolgente, che riesce ad attrarre molte persone, non sempre equivale a una produzione di qualità, ma in alcuni casi, come nella serie The last of us, si potrebbe scommettere di sì, in particolare grazie alle tematiche che i primi nove episodi ci hanno regalato. Alcune di queste sono state oggetto di singole puntate, come il rapporto tra il leader di una setta ispirata a principi religiosi e i suoi seguaci, oppure la riflessione in merito a un tema controverso come l’eutanasia; altre sono alla base degli eventi a catena che danno il via alla storia, come la questione dell’innalzamento della temperatura globale, tema che ha sicuramente permesso di coinvolgere Millennial e Gen Z, generazioni che tanto hanno a cuore la questione del cambiamento climatico e che sono le portatrici sane di una ecoansia che spesso non trova risonanza nelle scelte della politica, per la quale l’elettorato under 35 ha, numeri alla mano, troppo poco peso per valere davvero qualcosa.
La storia comincia con una piccola digressione: in un talk show degli anni Sessanta due studiosi si interrogano in merito alla possibile estinzione del genere umano causata da una pandemia, e da uno dei due emerge l’ipotesi secondo la quale il problema più serio con cui l’umanità avrebbe dovuto confrontarsi sarebbe stato quello dei funghi. L’ipotesi viene immediatamente rigettata come improbabile, data l’incapacità dei funghi di sopravvivere ad alte temperature, ma lo studioso continua imperterrito: se le temperature globali aumenteranno, i funghi si adatteranno e, allora, potranno trovare nell’uomo l’ospite perfetto. Peccato che non ci siano vaccini o cure per affrontare una situazione del genere. Da qui, con un salto in avanti di alcuni decenni, ci ritroviamo ad assistere ai primi giorni di diffusione di un fungo che, impossessatosi dei corpi degli esseri umani, ne intacca il cervello, spingendo ogni infetto ad attacchi violenti contro altri uomini e donne che, nel migliore dei casi, vengono uccisi in breve tempo e, nel peggiore, vengono infettati, trasformandosi anch’essi in creature semiumane dagli istinti incontrollabili.
La sfida, dunque, è quella di ripensare l’umano in un mondo che non avremmo mai immaginato. Non c’è una risposta univoca: nella serie ci troviamo a conoscere personaggi che cercano disperatamente di sopravvivere e diventano bestie, altri che riescono a non soccombere, altri ancora che si muovono tra questi due estremi.
La presentazione di un mondo apocalittico è stata una scelta narrativamente vincente. La domanda che allora sorge spontanea è come mai da sempre l’uomo provi fascinazione nei confronti di storie così macabre. Non bisogna sforzarsi molto, in effetti, per trovarne, anche in altri contesti. In un tempo non troppo lontano, per esempio, i racconti del folklore non erano storie zuccherine: lo testimonia la storia di Cenerentola, la quale nella versione dei fratelli Grimm ci racconta di sorellastre che si mozzano le dita dei piedi pur di farli entrare nella scarpetta e che vengono accecate da due colombelle. Ancora oggi, poi, non resistiamo ai racconti di cronaca nera, tanto che un certo giornalismo spregiudicato non si fa remore a infarcire di dettagli storie tragiche che, ricordiamolo, coinvolgono persone, non oggetti a disposizione dello sguardo altrui. La visione di serie del genere, dunque, non fa eccezione, ma a differenza delle storie reali, ci permette di fruirne senza problemi di natura etica. Tanto lo scopo è sempre lo stesso: poterci dire, ancora una volta, che non è capitato a noi, che non capiterà mai a noi. E, dall’altra parte, potersi comunque immedesimare nella stessa situazione e provare, al sicuro nelle nostre case, a immaginare come ci comporteremmo se fossimo tra i personaggi di quella storia, cosa giudicheremmo giusto e cosa no, quali valori per noi insindacabili potremmo mettere da parte pur di sopravvivere.
Viene naturale confrontare la serie con un libro famosissimo, Cecità di Saramago, che come The last of us ci ricorda quanto l’uomo possa perdere la bussola in condizioni di estremo bisogno. La prospettiva analizzata, però, è opposta: in Saramago si nota il degrado delle condizioni a cui si lasciano andare i malati, nella serie tv quello a cui si abbandonano i sopravvissuti. Dall’una e dall’altra parte c’è il terrore, che li muove nella consapevolezza che nulla tornerà più come prima. Nel secondo episodio questa sensazione si fa più forte: non essendoci cure, ciò che resta da fare è bombardare. Bombardare intere città nella speranza che l’infezione venga contenuta. In un mondo dove la morte di centinaia di persone è auspicabile, qualsiasi freno morale viene a mancare.
Nonostante ciò, c’è chi nella brutalità del quotidiano riesce a coltivare germi di speranza, e sono forse questi i personaggi che ci aiutano a continuare la visione. Ci ricordano che possiamo anche noi fare qualcosa perché, citando il famoso explicit di Calvino ne Le città invisibili, è importante «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».
È quello che tentano di fare Frank e Bill, protagonisti della terza puntata, che provano a vivere una normalità che ormai non è più concessa a molti. Se Bill, infatti, ha ben presenti le insidie di questo nuovo mondo, in cui ogni contatto porta in sé il rischio del contagio e la possibilità di una morte violenta, Frank invece non rinuncia alla speranza, coltiva la bellezza, e lo insegna a Bill. Una scena potentissima è quella in cui egli baratta una pistola in cambio di alcuni semi di fragole, le mostra a Bill e gliele fa mangiare. Il sottotesto è chiaro: bisogna mettere da parte la violenza e ritornare ad apprezzare le piccole cose della vita, a prendersene cura. A questa prima interpretazione, tuttavia, ne aggiungo un’altra, giacché mi sembra anche che la contrapposizione sia tra l’utile e il superfluo: la pistola, in quanto tale, è necessaria, perché assicura una chance di salvezza; si potrebbe invece sopravvivere senza mangiare fragole (d’altronde Frank e Bill non ne mangiano da tempo), eppure sembra proprio che il superfluo, la bellezza per la bellezza in altre parole, diventi necessario nell’affermazione della propria umanità ritrovata.
Se facessimo solo ciò che ci permette la sopravvivenza, in che cosa ci differenzieremmo dalle bestie? Non sono forse la pratica del superfluo, l’imparare la Bellezza e, con essa, il Vero, e il Bene, letti insieme in una prospettiva filosofica, che ci rendono davvero umani? La risposta ce la dà l’episodio stesso. Anni dopo, infatti, vediamo un Bill diverso, e di sfuggita lo notiamo annaffiare un vaso di fiori: ha imparato anche lui l’arte del prendersi cura. Sa che non sono tempo, acqua, risorse sprecate quelle che gli servono per rendere bello il giardino di casa sua. Potrebbe fare a meno di quei fiori, ma sceglie di non farlo: sceglie di vivere in un mondo in cui c’è spazio anche per l’in-utile, cioè per ciò che non dà guadagno, e che pertanto non ha prezzo. Lo fa perché qualcun altro glielo ha mostrato, perché nella relazione lui è diventato più umano, ed è forse questo quello che la serie, con la sua sovrastruttura distopica, in realtà ci vuole raccontare.
Non è da meno il rapporto tra i due protagonisti, Joel, un uomo di mezza età, ed Ellie, una ragazzina che potrebbe cambiare le sorti dell’intero pianeta. Joel ha perso la figlia Sarah all’inizio della pandemia; Ellie ha vissuto orrori che l’hanno segnata profondamente. Il corso degli eventi li spinge, controvoglia, ad affrontare un viaggio assieme, e ciascuno dei due accetta semplicemente perché per entrambi la presenza dell’altro è funzionale. Si incamminano dunque verso la meta ma, inevitabilmente, inizieranno a volersi bene. Il piccolo miracolo a cui assistiamo sullo schermo e che abbiamo già visto in Bill e Frank è quello in cui tutti noi possiamo immedesimarci: le relazioni che curano le nostre ferite, e ci salvano. L’importanza di questo rapporto nato per necessità emerge chiaramente in due episodi: nel sesto, quando Joel in un primo momento sceglie di allontanarsi da Ellie per il suo bene, ma si rende poi conto che una relazione autentica non può essere fatta di scelte a direzione unica, scelte che non lasciano libertà all’altro; e nel finale di stagione, quando lei afferma che «il tempo guarisce le ferite» e lui le fa capire che non è stato il tempo ad averlo guarito, ma lei. La tenerezza di questo piccolo scambio ci restituisce la potenza di una relazione tra quelli che ormai, nonostante non lo siano biologicamente, si sentono padre e figlia.
Tanto ancora si potrebbe aggiungere su questi due personaggi ma, come detto al principio, lasciamo che il passaparola faccia la sua parte.